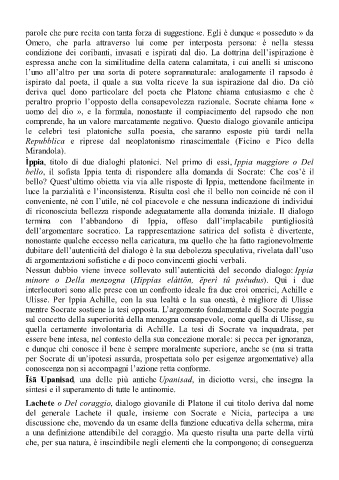Page 930 - Dizionario di Filosofia
P. 930
parole che pure recita con tanta forza di suggestione. Egli è dunque « posseduto » da
Omero, che parla attraverso lui come per interposta persona: è nella stessa
condizione dei coribanti, invasati e ispirati dal dio. La dottrina dell’ispirazione è
espressa anche con la similitudine della catena calamitata, i cui anelli si uniscono
l’uno all’altro per una sorta di potere soprannaturale: analogamente il rapsodo è
ispirato dal poeta, il quale a sua volta riceve la sua ispirazione dal dio. Da ciò
deriva quel dono particolare del poeta che Platone chiama entusiasmo e che è
peraltro proprio l’opposto della consapevolezza razionale. Socrate chiama Ione «
uomo del dio », e la formula, nonostante il compiacimento del rapsodo che non
comprende, ha un valore marcatamente negativo. Questo dialogo giovanile anticipa
le celebri tesi platoniche sulla poesia, che saranno esposte più tardi nella
Repubblica e riprese dal neoplatonismo rinascimentale (Ficino e Pico della
Mirandola).
Ìppia, titolo di due dialoghi platonici. Nel primo di essi, Ippia maggiore o Del
bello, il sofista Ippia tenta di rispondere alla domanda di Socrate: Che cos’è il
bello? Quest’ultimo obietta via via alle risposte di Ippia, mettendone facilmente in
luce la parzialità e l’inconsistenza. Risulta così che il bello non coincide né con il
conveniente, né con l’utile, né col piacevole e che nessuna indicazione di individui
di riconosciuta bellezza risponde adeguatamente alla domanda iniziale. Il dialogo
termina con l’abbandono di Ippia, offeso dall’implacabile puntigliosità
dell’argomentare socratico. La rappresentazione satirica del sofista è divertente,
nonostante qualche eccesso nella caricatura, ma quello che ha fatto ragionevolmente
dubitare dell’autenticità del dialogo è la sua debolezza speculativa, rivelata dall’uso
di argomentazioni sofistiche e di poco convincenti giochi verbali.
Nessun dubbio viene invece sollevato sull’autenticità del secondo dialogo: Ippia
minore o Della menzogna (Hippías eláttōn, ēperì tû pséudus). Qui i due
interlocutori sono alle prese con un confronto ideale fra due eroi omerici, Achille e
Ulisse. Per Ippia Achille, con la sua lealtà e la sua onestà, è migliore di Ulisse,
mentre Socrate sostiene la tesi opposta. L’argomento fondamentale di Socrate poggia
sul concetto della superiorità della menzogna consapevole, come quella di Ulisse, su
quella certamente involontaria di Achille. La tesi di Socrate va inquadrata, per
essere bene intesa, nel contesto della sua concezione morale: si pecca per ignoranza,
e dunque chi conosce il bene è sempre moralmente superiore, anche se (ma si tratta
per Socrate di un’ipotesi assurda, prospettata solo per esigenze argomentative) alla
conoscenza non si accompagni l’azione retta conforme.
Īśā Upanisad, una delle più antiche Upanisad, in diciotto versi, che insegna la
sintesi e il superamento di tutte le antinomie.
Lachete o Del coraggio, dialogo giovanile di Platone il cui titolo deriva dal nome
del generale Lachete il quale, insieme con Socrate e Nicia, partecipa a una
discussione che, movendo da un esame della funzione educativa della scherma, mira
a una definizione attendibile del coraggio. Ma questo risulta una parte della virtù
che, per sua natura, è inscindibile negli elementi che la compongono; di conseguenza