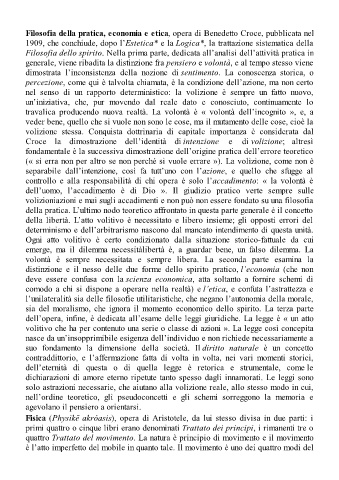Page 926 - Dizionario di Filosofia
P. 926
Filosofia della pratica, economia e etica, opera di Benedetto Croce, pubblicata nel
1909, che conchiude, dopo l’Estetica* e la Logica*, la trattazione sistematica della
Filosofia dello spirito. Nella prima parte, dedicata all’analisi dell’attività pratica in
generale, viene ribadita la distinzione fra pensiero e volontà, e al tempo stesso viene
dimostrata l’inconsistenza della nozione di sentimento. La conoscenza storica, o
percezione, come qui è talvolta chiamata, è la condizione dell’azione, ma non certo
nel senso di un rapporto deterministico: la volizione è sempre un fatto nuovo,
un’iniziativa, che, pur movendo dal reale dato e conosciuto, continuamente lo
travalica producendo nuova realtà. La volontà è « volontà dell’incognito », e, a
veder bene, quello che si vuole non sono le cose, ma il mutamento delle cose, cioè la
volizione stessa. Conquista dottrinaria di capitale importanza è considerata dal
Croce la dimostrazione dell’identità di intenzione e di volizione; altresì
fondamentale è la successiva dimostrazione dell’origine pratica dell’errore teoretico
(« si erra non per altro se non perché si vuole errare »). La volizione, come non è
separabile dall’intenzione, così fa tutt’uno con l’azione, e quello che sfugge al
controllo e alla responsabilità di chi opera è solo l’accadimento: « la volontà è
dell’uomo, l’accadimento è di Dio ». Il giudizio pratico verte sempre sulle
volizioniazioni e mai sugli accadimenti e non può non essere fondato su una filosofia
della pratica. L’ultimo nodo teoretico affrontato in questa parte generale è il concetto
della libertà. L’atto volitivo è necessitato e libero insieme; gli opposti errori del
determinismo e dell’arbitrarismo nascono dal mancato intendimento di questa unità.
Ogni atto volitivo è certo condizionato dalla situazione storico-fattuale da cui
emerge, ma il dilemma necessitàlibertà è, a guardar bene, un falso dilemma. La
volontà è sempre necessitata e sempre libera. La seconda parte esamina la
distinzione e il nesso delle due forme dello spirito pratico, l’economia (che non
deve essere confusa con la scienza economica, atta soltanto a fornire schemi di
comodo a chi si dispone a operare nella realtà) e l’etica, e confuta l’astrattezza e
l’unilateralità sia delle filosofie utilitaristiche, che negano l’autonomia della morale,
sia del moralismo, che ignora il momento economico dello spirito. La terza parte
dell’opera, infine, è dedicata all’esame delle leggi giuridiche. La legge è « un atto
volitivo che ha per contenuto una serie o classe di azioni ». La legge così concepita
nasce da un’insopprimibile esigenza dell’individuo e non richiede necessariamente a
suo fondamento la dimensione della società. Il diritto naturale è un concetto
contraddittorio, e l’affermazione fatta di volta in volta, nei vari momenti storici,
dell’eternità di questa o di quella legge è retorica e strumentale, come le
dichiarazioni di amore eterno ripetute tanto spesso dagli innamorati. Le leggi sono
solo astrazioni necessarie, che aiutano alla volizione reale, allo stesso modo in cui,
nell’ordine teoretico, gli pseudoconcetti e gli schemi sorreggono la memoria e
agevolano il pensiero a orientarsi.
Fisica (Physikē akróasis), opera di Aristotele, da lui stesso divisa in due parti: i
primi quattro o cinque libri erano denominati Trattato dei principi, i rimanenti tre o
quattro Trattato del movimento. La natura è principio di movimento e il movimento
è l’atto imperfetto del mobile in quanto tale. Il movimento è uno dei quattro modi del