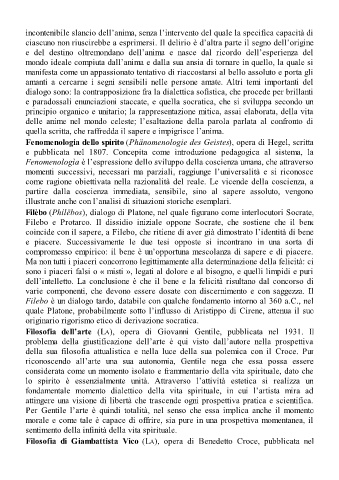Page 924 - Dizionario di Filosofia
P. 924
incontenibile slancio dell’anima, senza l’intervento del quale la specifica capacità di
ciascuno non riuscirebbe a esprimersi. Il delirio è d’altra parte il segno dell’origine
e del destino oltremondano dell’anima e nasce dal ricordo dell’esperienza del
mondo ideale compiuta dall’anima e dalla sua ansia di tornare in quello, la quale si
manifesta come un appassionato tentativo di riaccostarsi al bello assoluto e porta gli
amanti a cercarne i segni sensibili nelle persone amate. Altri temi importanti del
dialogo sono: la contrapposizione fra la dialettica sofistica, che procede per brillanti
e paradossali enunciazioni staccate, e quella socratica, che si sviluppa secondo un
principio organico e unitario; la rappresentazione mitica, assai elaborata, della vita
delle anime nel mondo celeste; l’esaltazione della parola parlata al confronto di
quella scritta, che raffredda il sapere e impigrisce l’anima.
Fenomenologia dello spirito (Phänomenologie des Geistes), opera di Hegel, scritta
e pubblicata nel 1807. Concepita come introduzione pedagogica al sistema, la
Fenomenologìa è l’espressione dello sviluppo della coscienza umana, che attraverso
momenti successivi, necessari ma parziali, raggiunge l’universalità e si riconosce
come ragione obiettivata nella razionalità del reale. Le vicende della coscienza, a
partire dalla coscienza immediata, sensibile, sino al sapere assoluto, vengono
illustrate anche con l’analisi di situazioni storiche esemplari.
Filèbo (Phílēbos), dialogo di Platone, nel quale figurano come interlocutori Socrate,
Filebo e Protarco. Il dissidio iniziale oppone Socrate, che sostiene che il bene
coincide con il sapere, a Filebo, che ritiene di aver già dimostrato l’identità di bene
e piacere. Successivamente le due tesi opposte si incontrano in una sorta di
compromesso empirico: il bene è un’opportuna mescolanza di sapere e di piacere.
Ma non tutti i piaceri concorrono legittimamente alla determinazione della felicità: ci
sono i piaceri falsi o « misti », legati al dolore e al bisogno, e quelli limpidi e puri
dell’intelletto. La conclusione è che il bene e la felicità risultano dal concorso di
varie componenti, che devono essere dosate con discernimento e con saggezza. Il
Filebo è un dialogo tardo, databile con qualche fondamento intorno al 360 a.C., nel
quale Platone, probabilmente sotto l’influsso di Aristippo di Cirene, attenua il suo
originario rigorismo etico di derivazione socratica.
Filosofia dell’arte (LA), opera di Giovanni Gentile, pubblicata nel 1931. Il
problema della giustificazione dell’arte è qui visto dall’autore nella prospettiva
della sua filosofia attualistica e nella luce della sua polemica con il Croce. Pur
riconoscendo all’arte una sua autonomia, Gentile nega che essa possa essere
considerata come un momento isolato e frammentario della vita spirituale, dato che
lo spirito è essenzialmente unità. Attraverso l’attività estetica si realizza un
fondamentale momento dialettico della vita spirituale, in cui l’artista mira ad
attingere una visione di libertà che trascende ogni prospettiva pratica e scientifica.
Per Gentile l’arte è quindi totalità, nel senso che essa implica anche il momento
morale e come tale è capace di offrire, sia pure in una prospettiva momentanea, il
sentimento della infinità della vita spirituale.
Filosofia di Giambattista Vico (LA), opera di Benedetto Croce, pubblicata nel