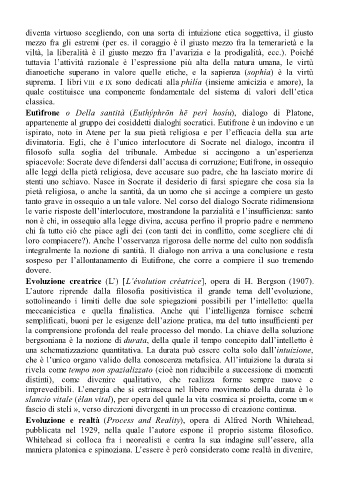Page 922 - Dizionario di Filosofia
P. 922
diventa virtuoso scegliendo, con una sorta di intuizione etica soggettiva, il giusto
mezzo fra gli estremi (per es. il coraggio è il giusto mezzo fra la temerarietà e la
viltà, la liberalità è il giusto mezzo fra l’avarizia e la prodigalità, ecc.). Poiché
tuttavia l’attività razionale è l’espressione più alta della natura umana, le virtù
dianoetiche superano in valore quelle etiche, e la sapienza (sophía) è la virtù
suprema. I libri VIII e IX sono dedicati alla philía (insieme amicizia e amore), la
quale costituisce una componente fondamentale del sistema di valori dell’etica
classica.
Eutìfrone o Della santità (Euthýphrōn hē perì hosíu), dialogo di Platone,
appartenente al gruppo dei cosiddetti dialoghi socratici. Eutifrone è un indovino e un
ispirato, noto in Atene per la sua pietà religiosa e per l’efficacia della sua arte
divinatoria. Egli, che è l’unico interlocutore di Socrate nel dialogo, incontra il
filosofo sulla soglia del tribunale. Ambedue si accingono a un’esperienza
spiacevole: Socrate deve difendersi dall’accusa di corruzione; Eutifrone, in ossequio
alle leggi della pietà religiosa, deve accusare suo padre, che ha lasciato morire di
stenti uno schiavo. Nasce in Socrate il desiderio di farsi spiegare che cosa sia la
pietà religiosa, o anche la santità, da un uomo che si accinge a compiere un gesto
tanto grave in ossequio a un tale valore. Nel corso del dialogo Socrate ridimensiona
le varie risposte dell’interlocutore, mostrandone la parzialità e l’insufficienza: santo
non è chi, in ossequio alla legge divina, accusa perfino il proprio padre e nemmeno
chi fa tutto ciò che piace agli dei (con tanti dei in conflitto, come scegliere chi di
loro compiacere?). Anche l’osservanza rigorosa delle norme del culto non soddisfa
integralmente la nozione di santità. Il dialogo non arriva a una conclusione e resta
sospeso per l’allontanamento di Eutifrone, che corre a compiere il suo tremendo
dovere.
Evoluzione creatrice (L’) [L’évolution créatrice], opera di H. Bergson (1907).
L’autore riprende dalla filosofia positivistica il grande tema dell’evoluzione,
sottolineando i limiti delle due sole spiegazioni possibili per l’intelletto: quella
meccanicistica e quella finalistica. Anche qui l’intelligenza fornisce schemi
semplificati, buoni per le esigenze dell’azione pratica, ma del tutto insufficienti per
la comprensione profonda del reale processo del mondo. La chiave della soluzione
bergsoniana è la nozione di durata, della quale il tempo concepito dall’intelletto è
una schematizzazione quantitativa. La durata può essere colta solo dall’intuizione,
che è l’unico organo valido della conoscenza metafisica. All’intuizione la durata si
rivela come tempo non spazializzato (cioè non riducibile a successione di momenti
distinti), come divenire qualitativo, che realizza forme sempre nuove e
imprevedibili. L’energia che si estrinseca nel libero movimento della durata è lo
slancio vitale (élan vital), per opera del quale la vita cosmica si proietta, come un «
fascio di steli », verso direzioni divergenti in un processo di creazione continua.
Evoluzione e realtà (Process and Reality), opera di Alfred North Whitehead,
pubblicata nel 1929, nella quale l’autore espone il proprio sistema filosofico.
Whitehead si colloca fra i neorealisti e centra la sua indagine sull’essere, alla
maniera platonica e spinoziana. L’essere è però considerato come realtà in divenire,