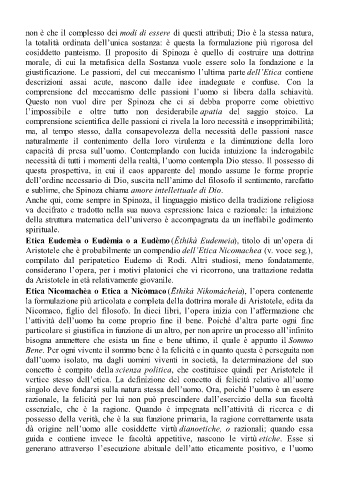Page 921 - Dizionario di Filosofia
P. 921
non è che il complesso dei modi di essere di questi attributi; Dio è la stessa natura,
la totalità ordinata dell’unica sostanza: è questa la formulazione più rigorosa del
cosiddetto panteismo. Il proposito di Spinoza è quello di costruire una dottrina
morale, di cui la metafìsica della Sostanza vuole essere solo la fondazione e la
giustificazione. Le passioni, del cui meccanismo l’ultima parte dell’Etica contiene
descrizioni assai acute, nascono dalle idee inadeguate e confuse. Con la
comprensione del meccanismo delle passioni l’uomo si libera dalla schiavitù.
Questo non vuol dire per Spinoza che ci si debba proporre come obiettivo
l’impossibile e oltre tutto non desiderabile apatia del saggio stoico. La
comprensione scientifica delle passioni ci rivela la loro necessità e insopprimibilità;
ma, al tempo stesso, dalla consapevolezza della necessità delle passioni nasce
naturalmente il contenimento della loro virulenza e la diminuzione della loro
capacità di presa sull’uomo. Contemplando con lucida intuizione la inderogabile
necessità di tutti i momenti della realtà, l’uomo contempla Dio stesso. Il possesso di
questa prospettiva, in cui il caos apparente del mondo assume le forme proprie
dell’ordine necessario di Dio, suscita nell’animo del filosofo il sentimento, rarefatto
e sublime, che Spinoza chiama amore intellettuale di Dio.
Anche qui, come sempre in Spinoza, il linguaggio mistico della tradizione religiosa
va decifrato e tradotto nella sua nuova espressione laica e razionale: la intuizione
della struttura matematica dell’universo è accompagnata da un ineffabile godimento
spirituale.
Etica Eudemèa o Eudèmia o a Eudèmo (Ēthikà Eudemeia), titolo di un’opera di
Aristotele che è probabilmente un compendio dell’Etica Nicomachea (v. voce seg.),
compilato dal peripatetico Eudemo di Rodi. Altri studiosi, meno fondatamente,
considerano l’opera, per i motivi platonici che vi ricorrono, una trattazione redatta
da Aristotele in età relativamente giovanile.
Etica Nicomachèa o Etica a Nicòmaco (Ēthikà Nikomácheia), l’opera contenente
la formulazione più articolata e completa della dottrina morale di Aristotele, edita da
Nicomaco, figlio del filosofo. In dieci libri, l’opera inizia con l’affermazione che
l’attività dell’uomo ha come proprio fine il bene. Poiché d’altra parte ogni fine
particolare si giustifica in funzione di un altro, per non aprire un processo all’infinito
bisogna ammettere che esista un fine e bene ultimo, il quale è appunto il Sommo
Bene. Per ogni vivente il sommo bene è la felicità e in quanto questa è perseguita non
dall’uomo isolato, ma dagli uomini viventi in società, la determinazione del suo
concetto è compito della scienza politica, che costituisce quindi per Aristotele il
vertice stesso dell’etica. La definizione del concetto di felicità relativo all’uomo
singolo deve fondarsi sulla natura stessa dell’uomo. Ora, poiché l’uomo è un essere
razionale, la felicità per lui non può prescindere dall’esercizio della sua facoltà
essenziale, che è la ragione. Quando è impegnata nell’attività di ricerca e di
possesso della verità, che è la sua funzione primaria, la ragione correttamente usata
dà origine nell’uomo alle cosiddette virtù dianoetiche, o razionali; quando essa
guida e contiene invece le facoltà appetitive, nascono le virtù etiche. Esse si
generano attraverso l’esecuzione abituale dell’atto eticamente positivo, e l’uomo