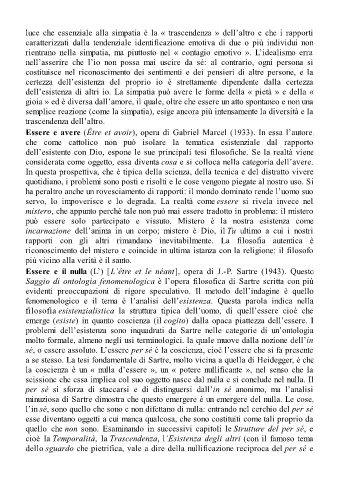Page 918 - Dizionario di Filosofia
P. 918
luce che essenziale alla simpatia è la « trascendenza » dell’altro e che i rapporti
caratterizzati dalla tendenziale identificazione emotiva di due o più individui non
rientrano nella simpatia, ma piuttosto nel « contagio emotivo ». L’idealismo erra
nell’asserire che l’io non possa mai uscire da sé: al contrario, ogni persona si
costituisce nel riconoscimento dei sentimenti e dei pensieri di altre persone, e la
certezza dell’esistenza del proprio io è strettamente dipendente dalla certezza
dell’esistenza di altri io. La simpatia può avere le forme della « pietà » e della «
gioia » ed è diversa dall’amore, il quale, oltre che essere un atto spontaneo e non una
semplice reazione (come la simpatia), esige ancora più intensamente la diversità e la
trascendenza dell’altro.
Essere e avere (Être et avoir), opera di Gabriel Marcel (1933). In essa l’autore,
che come cattolico non può isolare la tematica esistenziale dal rapporto
dell’esistente con Dio, espone le sue principali tesi filosofiche. Se la realtà viene
considerata come oggetto, essa diventa cosa e si colloca nella categoria dell’avere.
In questa prospettiva, che è tipica della scienza, della tecnica e del distratto vivere
quotidiano, i problemi sono posti e risolti e le cose vengono piegate al nostro uso. Si
ha peraltro anche un rovesciamento di rapporti: il mondo dominato rende l’uomo suo
servo, lo impoverisce e lo degrada. La realtà come essere si rivela invece nel
mistero, che appunto perché tale non può mai essere tradotto in problema: il mistero
può essere solo partecipato e vissuto. Mistero è la nostra esistenza come
incarnazione dell’anima in un corpo; mistero è Dio, il Tu ultimo a cui i nostri
rapporti con gli altri rimandano inevitabilmente. La filosofia autentica è
riconoscimento del mistero e coincide in ultima istanza con la religione: il filosofo
più vicino alla verità è il santo.
Essere e il nulla (L’) [L’être et le néant], opera di J.-P. Sartre (1943). Questo
Saggio di ontologia fenomenologica è l’opera filosofica di Sartre scritta con più
evidenti preoccupazioni di rigore speculativo. Il metodo dell’indagine è quello
fenomenologico e il tema è l’analisi dell’esistenza. Questa parola indica nella
filosofia esistenzialistica la struttura tipica dell’uomo, di quell’essere cioè che
emerge (esiste) in quanto coscienza (il cogito) dalla opaca piattezza dell’essere. I
problemi dell’esistenza sono inquadrati da Sartre nelle categorie di un’ontologia
molto formale, almeno negli usi terminologici. la quale muove dalla nozione dell’in
sé, o essere assoluto. L’essere per sé è la coscienza, cioè l’essere che si fa presente
a se stesso. La tesi fondamentale di Sartre, molto vicina a quella di Heidegger, è che
la coscienza è un « nulla d’essere », un « potere nullificante », nel senso che la
scissione che essa implica col suo oggetto nasce dal nulla e si conclude nel nulla. Il
per sé si sforza di staccarsi e di distinguersi dall’in sé anonimo, ma l’analisi
minuziosa di Sartre dimostra che questo emergere è un emergere del nulla. Le cose,
l’in sé, sono quello che sono e non difettano di nulla: entrando nel cerchio del per sé
esse diventano oggetti a cui manca qualcosa, che sono costituiti come tali proprio da
quello che non sono. Esaminando in successivi capitoli le Strutture del per sé, e
cioè la Temporalità, la Trascendenza, l’Esistenza degli altri (con il famoso tema
dello sguardo che pietrifica, vale a dire della nullificazione reciproca del per sé e