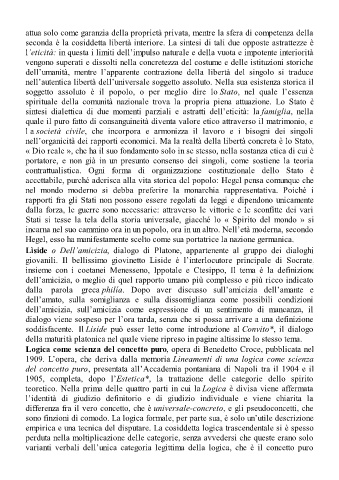Page 934 - Dizionario di Filosofia
P. 934
attua solo come garanzia della proprietà privata, mentre la sfera di competenza della
seconda è la cosiddetta libertà interiore. La sintesi di tali due opposte astrattezze è
l’eticità: in questa i limiti dell’impulso naturale e della vuota e impotente interiorità
vengono superati e dissolti nella concretezza del costume e delle istituzioni storiche
dell’umanità, mentre l’apparente contrazione della libertà del singolo si traduce
nell’autentica libertà dell’universale soggetto assoluto. Nella sua esistenza storica il
soggetto assoluto è il popolo, o per meglio dire lo Stato, nel quale l’essenza
spirituale della comunità nazionale trova la propria piena attuazione. Lo Stato è
sintesi dialettica di due momenti parziali e astratti dell’eticità: la famiglia, nella
quale il puro fatto di consanguineità diventa valore etico attraverso il matrimonio, e
l a società civile, che incorpora e armonizza il lavoro e i bisogni dei singoli
nell’organicità dei rapporti economici. Ma la realtà della libertà concreta è lo Stato,
« Dio reale », che ha il suo fondamento solo in se stesso, nella sostanza etica di cui è
portatore, e non già in un presunto consenso dei singoli, come sostiene la teoria
contrattualistica. Ogni forma di organizzazione costituzionale dello Stato è
accettabile, purché aderisca alla vita storica del popolo: Hegel pensa comunque che
nel mondo moderno si debba preferire la monarchia rappresentativa. Poiché i
rapporti fra gli Stati non possono essere regolati da leggi e dipendono unicamente
dalla forza, le guerre sono necessarie: attraverso le vittorie e le sconfitte dei vari
Stati si tesse la tela della storia universale, giacché lo « Spirito del mondo » si
incarna nel suo cammino ora in un popolo, ora in un altro. Nell’età moderna, secondo
Hegel, esso ha manifestamente scelto come sua portatrice la nazione germanica.
Lìside o Dell’amicizia, dialogo di Platone, appartenente al gruppo dei dialoghi
giovanili. Il bellissimo giovinetto Liside è l’interlocutore principale di Socrate,
insieme con i coetanei Menesseno, Ippotale e Ctesippo, Il tema è la definizione
dell’amicizia, o meglio di quel rapporto umano più complesso e più ricco indicato
dalla parola greca philía. Dopo aver discusso sull’amicizia dell’amante e
dell’amato, sulla somiglianza e sulla dissomiglianza come possibili condizioni
dell’amicizia, sull’amicizia come espressione di un sentimento di mancanza, il
dialogo viene sospeso per l’ora tarda, senza che si possa arrivare a una definizione
soddisfacente. Il Liside può esser letto come introduzione al Convito*, il dialogo
della maturità platonica nel quale viene ripreso in pagine altissime lo stesso tema.
Logica come scienza del concetto puro, opera di Benedetto Croce, pubblicata nel
1909. L’opera, che deriva dalla memoria Lineamenti di una logica come scienza
del concetto puro, presentata all’Accademia pontaniana di Napoli tra il 1904 e il
1905, completa, dopo l’Estetica*, la trattazione delle categorie dello spirito
teoretico. Nella prima delle quattro parti in cui la Logica è divisa viene affermata
l’identità di giudizio definitorio e di giudizio individuale e viene chiarita la
differenza fra il vero concetto, che è universale-concreto, e gli pseudoconcetti, che
sono finzioni di comodo. La logica formale, per parte sua, è solo un’utile descrizione
empirica e una tecnica del disputare. La cosiddetta logica trascendentale si è spesso
perduta nella moltiplicazione delle categorie, senza avvedersi che queste erano solo
varianti verbali dell’unica categoria legittima della logica, che è il concetto puro