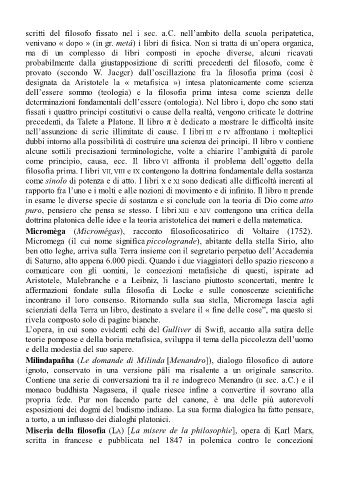Page 938 - Dizionario di Filosofia
P. 938
scritti del filosofo fissato nel i sec. a.C. nell’ambito della scuola peripatetica,
venivano « dopo » (in gr. metá) i libri di fisica. Non si tratta di un’opera organica,
ma di un complesso di libri composti in epoche diverse, alcuni ricavati
probabilmente dalla giustapposizione di scritti precedenti del filosofo, come è
provato (secondo W. Jaeger) dall’oscillazione fra la filosofia prima (così è
designata da Aristotele la « metafisica ») intesa platonicamente come scienza
dell’essere sommo (teologia) e la filosofia prima intesa come scienza delle
determinazioni fondamentali dell’essere (ontologia). Nel libro i, dopo che sono stati
fissati i quattro principi costitutivi o cause della realtà, vengono criticate le dottrine
precedenti, da Talete a Platone. Il libro π è dedicato a mostrare le difficoltà insite
nell’assunzione di serie illimitate di cause. I libri III e IV affrontano i molteplici
dubbi intorno alla possibilità di costruire una scienza dei principi. Il libro v contiene
alcune sottili precisazioni terminologiche, volte a chiarire l’ambiguità di parole
come principio, causa, ecc. Il libro VI affronta il problema dell’oggetto della
filosofia prima. I libri VII, VIII e IX contengono la dottrina fondamentale della sostanza
come sinolo di potenza e di atto. I libri x e XI sono dedicati alle difficoltà inerenti al
rapporto fra l’uno e i molti e alle nozioni di movimento e di infinito. Il libro II prende
in esame le diverse specie di sostanza e si conclude con la teoria di Dio come atto
puro, pensiero che pensa se stesso. I libri XIII e XIV contengono una critica della
dottrina platonica delle idee e la teoria aristotelica dei numeri e della matematica.
Micromèga (Micromégas), racconto filosoficosatirico di Voltaire (1752).
Micromega (il cui nome significa piccologrande), abitante della stella Sirio, alto
ben otto leghe, arriva sulla Terra insieme con il segretario perpetuo dell’Accademia
di Saturno, alto appena 6.000 piedi. Quando i due viaggiatori dello spazio riescono a
comunicare con gli uomini, le concezioni metafisiche di questi, ispirate ad
Aristotele, Malebranche e a Leibniz, li lasciano piuttosto sconcertati, mentre le
affermazioni fondate sulla filosofia di Locke e sulle conoscenze scientifiche
incontrano il loro consenso. Ritornando sulla sua stella, Micromega lascia agli
scienziati della Terra un libro, destinato a svelare il « fine delle cose”, ma questo si
rivela composto solo di pagine bianche.
L’opera, in cui sono evidenti echi del Gulliver di Swift, accanto alla satira delle
teorie pompose e della boria metafìsica, sviluppa il tema della piccolezza dell’uomo
e della modestia del suo sapere.
Milindapañha (Le domande di Milinda [Menandro]), dialogo filosofico di autore
ignoto, conservato in una versione pāli ma risalente a un originale sanscrito.
Contiene una serie di conversazioni tra il re indogreco Menandro (II sec. a.C.) e il
monaco buddhista Nagasena, il quale riesce infine a convertire il sovrano alla
propria fede. Pur non facendo parte del canone, è una delle più autorevoli
esposizioni dei dogmi del budismo indiano. La sua forma dialogica ha fatto pensare,
a torto, a un influsso dei dialoghi platonici.
Miseria della filosofia (LA) [La misere de la philosophie], opera di Karl Marx,
scritta in francese e pubblicata nel 1847 in polemica contro le concezioni