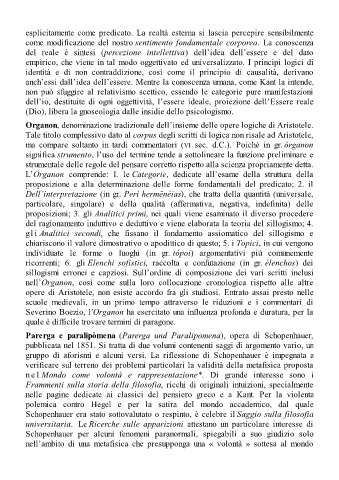Page 943 - Dizionario di Filosofia
P. 943
esplicitamente come predicato. La realtà esterna si lascia percepire sensibilmente
come modificazione del nostro sentimento fondamentale corporeo. La conoscenza
del reale è sintesi (percezione intellettiva) dell’idea dell’essere e del dato
empirico, che viene in tal modo oggettivato ed universalizzato. I principi logici di
identità e di non contraddizione, così come il principio di causalità, derivano
anch’essi dall’idea dell’essere. Mentre la conoscenza umana, come Kant la intende,
non può sfuggire al relativismo scettico, essendo le categorie pure manifestazioni
dell’io, destituite di ogni oggettività, l’essere ideale, proiezione dell’Essere reale
(Dio), libera la gnoseologia dalle insidie dello psicologismo.
Organon, denominazione tradizionale dell’insieme delle opere logiche di Aristotele.
Tale titolo complessivo dato al corpus degli scritti di logica non risale ad Aristotele,
ma compare soltanto in tardi commentatori (VI sec. d.C.). Poiché in gr. órganon
significa strumento, l’uso del termine tende a sottolineare la funzione preliminare e
strumentale delle regole del pensare corretto rispetto alla scienza propriamente detta.
L’Organon comprende: l. le Categorie, dedicate all’esame della struttura della
proposizione e alla determinazione delle forme fondamentali del predicato; 2. il
Dell’interpretazione (in gr. Perì hermēnéias), che tratta della quantità (universale,
particolare, singolare) e della qualità (affermativa, negativa, indefinita) delle
proposizioni; 3. gli Analitici primi, nei quali viene esaminato il diverso procedere
del ragionamento induttivo e deduttivo e viene elaborata la teoria del sillogismo; 4.
gl i Analitici secondi, che fissano il fondamento assiomatico del sillogismo e
chiariscono il valore dimostrativo o apodittico di questo; 5. i Topici, in cui vengono
individuate le forme o luoghi (in gr. tópoi) argomentativi più comunemente
ricorrenti; 6. gli Elenchi sofistici, raccolta e confutazione (in gr. élenchos) dei
sillogismi erronei e capziosi. Sull’ordine di composizione dei vari scritti inclusi
nell’Organon, così come sulla loro collocazione cronologica rispetto alle altre
opere di Aristotele, non esiste accordo fra gli studiosi. Entrato assai presto nelle
scuole medievali, in un primo tempo attraverso le riduzioni e i commentari di
Severino Boezio, l’Organon ha esercitato una influenza profonda e duratura, per la
quale è difficile trovare termini di paragone.
Parerga e paralipòmena (Parerga und Paralipomena), opera di Schopenhauer,
pubblicata nel 1851. Si tratta di due volumi contenenti saggi di argomento vario, un
gruppo di aforismi e alcuni versi. La riflessione di Schopenhauer è impegnata a
verificare sul terreno dei problemi particolari la validità della metafisica proposta
ne l Mondo come volontà e rappresentazione*. Di grande interesse sono i
Frammenti sulla storia della filosofia, ricchi di originali intuizioni, specialmente
nelle pagine dedicate ai classici del pensiero greco e a Kant. Per la violenta
polemica contro Hegel e per la satira del mondo accademico, dal quale
Schopenhauer era stato sottovalutato o respinto, è celebre il Saggio sulla filosofia
universitaria. Le Ricerche sulle apparizioni attestano un particolare interesse di
Schopenhauer per alcuni fenomeni paranormali, spiegabili a suo giudizio solo
nell’ambito di una metafisica che presupponga una « volontà » sottesa al mondo