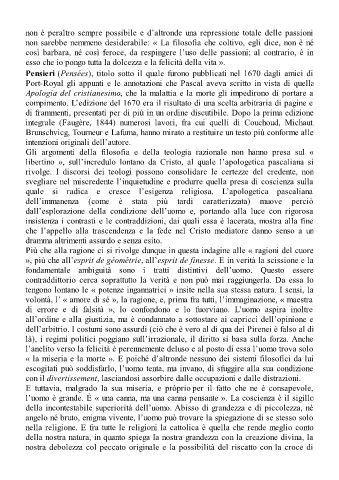Page 945 - Dizionario di Filosofia
P. 945
non è peraltro sempre possibile e d’altronde una repressione totale delle passioni
non sarebbe nemmeno desiderabile: « La filosofia che coltivo, egli dice, non è né
così barbara, né così feroce, da respingere l’uso delle passioni; al contrario, è in
esso che io pongo tutta la dolcezza e la felicità della vita ».
Pensieri (Pensées), titolo sotto il quale furono pubblicati nel 1670 dagli amici di
Port-Royal gli appunti e le annotazioni che Pascal aveva scritto in vista di quella
Apologia del cristianesimo, che la malattia e la morte gli impedirono di portare a
compimento. L’edizione del 1670 era il risultato di una scelta arbitraria di pagine e
di frammenti, presentati per di più in un ordine discutibile. Dopo la prima edizione
integrale (Faugère, 1844) numerosi lavori, fra cui quelli di Couchoud, Michaut,
Brunschvicg, Tourneur e Lafuma, hanno mirato a restituire un testo più conforme alle
intenzioni originali dell’autore.
Gli argomenti della filosofia e della teologia razionale non hanno presa sul «
libertino », sull’incredulo lontano da Cristo, al quale l’apologetica pascaliana si
rivolge. I discorsi dei teologi possono consolidare le certezze del credente, non
svegliare nel miscredente l’inquietudine e produrre quella presa di coscienza sulla
quale si radica e cresce l’esigenza religiosa. L’apologetica pascaliana
dell’immanenza (come è stata più tardi caratterizzata) muove perciò
dall’esplorazione della condizione dell’uomo e, portando alla luce con rigorosa
insistenza i contrasti e le contraddizioni, dai quali essa è lacerata, mostra alla fine
che l’appello alla trascendenza e la fede nel Cristo mediatore danno senso a un
dramma altrimenti assurdo e senza esito.
Più che alla ragione ci si rivolge dunque in questa indagine alle « ragioni del cuore
», più che all’esprit de géométrie, all’esprit de finesse. E in verità la scissione e la
fondamentale ambiguità sono i tratti distintivi dell’uomo. Questo essere
contraddittorio cerca soprattutto la verità e non può mai raggiungerla. Da essa lo
tengono lontano le « potenze ingannatrici » insite nella sua stessa natura. I sensi, la
volontà, l’ « amore di sé », la ragione, e, prima fra tutti, l’immaginazione, « maestra
di errore e di falsità », lo confondono e lo fuorviano. L’uomo aspira inoltre
all’ordine e alla giustizia, ma è condannato a sottostare ai capricci dell’opinione e
dell’arbitrio. I costumi sono assurdi (ciò che è vero al di qua dei Pirenei è falso al di
là), i regimi politici poggiano sull’irrazionale, il diritto si basa sulla forza. Anche
l’anelito verso la felicità è perennemente deluso e al posto di essa l’uomo trova solo
« la miseria e la morte ». E poiché d’altronde nessuno dei sistemi filosofici da lui
escogitati può soddisfarlo, l’uomo tenta, ma invano, di sfuggire alla sua condizione
con il divertissement, lasciandosi assorbire dalle occupazioni e dalle distrazioni.
E tuttavia, malgrado la sua miseria, e pròprio per il fatto che ne è consapevole,
l’uomo è grande. È « una canna, ma una canna pensante ». La coscienza è il sigillo
della incontestabile superiorità dell’uomo. Abisso di grandezza e di piccolezza, né
angelo né bruto, enigma vivente, l’uomo può trovare la spiegazione di se stesso solo
nella religione. E fra tutte le religioni la cattolica è quella che rende meglio conto
della nostra natura, in quanto spiega la nostra grandezza con la creazione divina, la
nostra debolezza col peccato originale e la possibilità del riscatto con la croce di