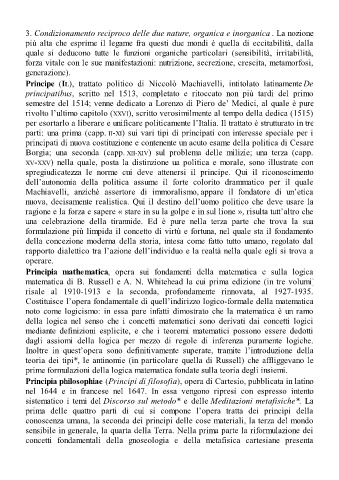Page 949 - Dizionario di Filosofia
P. 949
3. Condizionamento reciproco delle due nature, organica e inorganica . La nozione
più alta che esprime il legame fra questi due mondi è quella di eccitabilità, dalla
quale si deducono tutte le funzioni organiche particolari (sensibilità, irritabilità,
forza vitale con le sue manifestazioni: nutrizione, secrezione, crescita, metamorfosi,
generazione).
Principe (IL), trattato politico di Niccolò Machiavelli, intitolato latinamente De
principatibus, scritto nel 1513, completato e ritoccato non più tardi del primo
semestre del 1514; venne dedicato a Lorenzo di Piero de’ Medici, al quale è pure
rivolto l’ultimo capitolo (XXVI), scritto verosimilmente al tempo della dedica (1515)
per esortarlo a liberare e unificare politicamente l’Italia. Il trattato è strutturato in tre
parti: una prima (capp. II-XI) sui vari tipi di principati con interesse speciale per i
principati di nuova costituzione e contenente un acuto esame della politica di Cesare
Borgia; una seconda (capp. XII-XIV) sul problema delle milizie; una terza (capp.
XV-XXV) nella quale, posta la distinzione ua politica e morale, sono illustrate con
spregiudicatezza le norme cui deve attenersi il principe. Qui il riconoscimento
dell’autonomia della politica assume il forte colorito drammatico per il quale
Machiavelli, anziché assertore di immoralismo, appare il fondatore di un’etica
nuova, decisamente realistica. Qui il destino dell’uomo politico che deve usare la
ragione e la forza e sapere « stare in su la golpe e in sul lione », risulta tutt’altro che
una celebrazione della tirannide. Ed è pure nella terza parte che trova la sua
formulazione più limpida il concetto di virtù e fortuna, nel quale sta il fondamento
della concezione moderna della storia, intesa come fatto tutto umano, regolato dal
rapporto dialettico tra l’azione dell’individuo e la realtà nella quale egli si trova a
operare.
Principia mathematica, opera sui fondamenti della matematica e sulla logica
matematica di B. Russell e A. N. Whitehead la cui prima edizione (in tre volumi)
risale al 1910-1913 e la seconda, profondamente rinnovata, al 1927-1935.
Costituisce l’opera fondamentale di quell’indirizzo logico-formale della matematica
noto come logicismo: in essa pare infatti dimostrato che la matematica è un ramo
della logica nel senso che i concetti matematici sono derivati dai concetti logici
mediante definizioni esplicite, e che i teoremi matematici possono essere dedotti
dagli assiomi della logica per mezzo di regole di inferenza puramente logiche.
Inoltre in quest’opera sono definitivamente superate, tramite l’introduzione della
teoria dei tipi*, le antinomie (in particolare quella di Russell) che affliggevano le
prime formulazioni della logica matematica fondate sulla teoria degli insiemi.
Principia philosophiae (Principi di filosofia), opera di Cartesio, pubblicata in latino
nel 1644 e in francese nel 1647. In essa vengono ripresi con espresso intento
sistematico i temi del Discorso sul metodo* e delle Meditazioni metafisiche*. La
prima delle quattro parti di cui si compone l’opera tratta dei principi della
conoscenza umana, la seconda dei principi delle cose materiali, la terza del mondo
sensibile in generale, la quarta della Terra. Nella prima parte la riformulazione dei
concetti fondamentali della gnoseologia e della metafisica cartesiane presenta