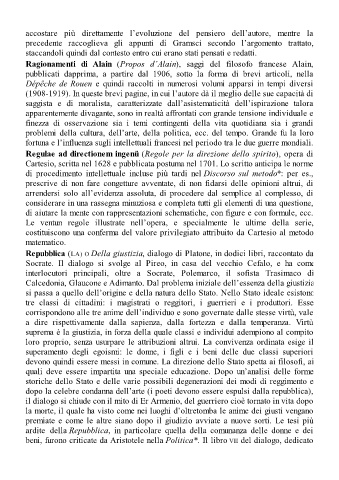Page 951 - Dizionario di Filosofia
P. 951
accostare più direttamente l’evoluzione del pensiero dell’autore, mentre la
precedente raccoglieva gli appunti di Gramsci secondo l’argomento trattato,
staccandoli quindi dal contesto entro cui erano stati pensati e redatti.
Ragionamenti di Alain (Propos d’Alain), saggi del filosofo francese Alain,
pubblicati dapprima, a partire dal 1906, sotto la forma di brevi articoli, nella
Dépêche de Rouen e quindi raccolti in numerosi volumi apparsi in tempi diversi
(1908-1919). In queste brevi pagine, in cui l’autore dà il meglio delle sue capacità di
saggista e di moralista, caratterizzate dall’asistematicità dell’ispirazione talora
apparentemente divagante, sono in realtà affrontati con grande tensione individuale e
finezza di osservazione sia i temi contingenti della vita quotidiana sia i grandi
problemi della cultura, dell’arte, della politica, ecc. del tempo. Grande fu la loro
fortuna e l’influenza sugli intellettuali francesi nel periodo tra le due guerre mondiali.
Regulae ad directionem ingenü (Regole per la direzione dello spirito), opera di
Cartesio, scritta nel 1628 e pubblicata postuma nel 1701. Lo scritto anticipa le norme
di procedimento intellettuale incluse più tardi nel Discorso sul metodo*: per es.,
prescrive di non fare congetture avventate, di non fidarsi delle opinioni altrui, di
arrendersi solo all’evidenza assoluta, di procedere dal semplice al complesso, di
considerare in una rassegna minuziosa e completa tutti gli elementi di una questione,
di aiutare la mente con rappresentazioni schematiche, con figure e con formule, ecc.
Le ventun regole illustrate nell’opera, e specialmente le ultime della serie,
costituiscono una conferma del valore privilegiato attribuito da Cartesio al metodo
matematico.
Repubblica (LA) O Della giustizia, dialogo di Platone, in dodici libri, raccontato da
Socrate. Il dialogo si svolge al Pireo, in casa del vecchio Cefalo, e ha come
interlocutori principali, oltre a Socrate, Polemarco, il sofista Trasimaco di
Calcedonia, Glaucone e Adimanto. Dal problema iniziale dell’essenza della giustizia
si passa a quello dell’origine e della natura dello Stato. Nello Stato ideale esistono
tre classi di cittadini: i magistrati o reggitori, i guerrieri e i produttori. Esse
corrispondono alle tre anime dell’individuo e sono governate dalle stesse virtù, vale
a dire rispettivamente dalla sapienza, dalla fortezza e dalla temperanza. Virtù
suprema è la giustizia, in forza della quale classi e individui adempiono al compito
loro proprio, senza usurpare le attribuzioni altrui. La convivenza ordinata esige il
superamento degli egoismi: le donne, i figli e i beni delle due classi superiori
devono quindi essere messi in comune. La direzione dello Stato spetta ai filosofi, ai
quali deve essere impartita una speciale educazione. Dopo un’analisi delle forme
storiche dello Stato e delle varie possibili degenerazioni dei modi di reggimento e
dopo la celebre condanna dell’arte (i poeti devono essere espulsi dalla repubblica),
il dialogo si chiude con il mito di Er Armenio, del guerriero cioè tornato in vita dopo
la morte, il quale ha visto come nei luoghi d’oltretomba le anime dei giusti vengano
premiate e come le altre siano dopo il giudizio avviate a nuove sorti. Le tesi più
ardite della Repubblica, in particolare quella della comunanza delle donne e dei
beni, furono criticate da Aristotele nella Politica*. Il libro VII del dialogo, dedicato