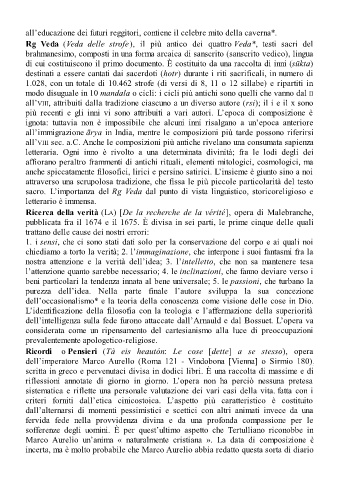Page 952 - Dizionario di Filosofia
P. 952
all’educazione dei futuri reggitori, contiene il celebre mito della caverna*.
Rg Veda (Veda delle strofe), il più antico dei quattro Veda*, testi sacri del
brahmanesimo, composti in una forma arcaica di sanscrito (sanscrito vedico), lingua
di cui costituiscono il primo documento. È costituito da una raccolta di inni (sūkta)
destinati a essere cantati dai sacerdoti (hotr) durante i riti sacrificali, in numero di
1.028, con un totale di 10.462 strofe (di versi di 8, 11 o 12 sillabe) e ripartiti in
modo disuguale in 10 mandala o cicli: i cicli più antichi sono quelli che vanno dal II
all’VIII, attribuiti dalla tradizione ciascuno a un diverso autore (rsi); il i e il x sono
più recenti e gli inni vi sono attribuiti a vari autori. L’epoca di composizione è
ignota: tuttavia non è impossibile che alcuni inni risalgano a un’epoca anteriore
all’immigrazione ārya in India, mentre le composizioni più tarde possono riferirsi
all’VIII sec. a.C. Anche le composizioni più antiche rivelano una consumata sapienza
letteraria. Ogni inno è rivolto a una determinata divinità; fra le lodi degli dei
affiorano peraltro frammenti di antichi rituali, elementi mitologici, cosmologici, ma
anche spiccatamente filosofici, lirici e persino satirici. L’insieme è giunto sino a noi
attraverso una scrupolosa tradizione, che fissa le più piccole particolarità del testo
sacro. L’importanza del Rg Veda dal punto di vista linguistico, storicoreligioso e
letterario è immensa.
Ricerca della verità (LA) [De la recherche de la vérité], opera di Malebranche,
pubblicata fra il 1674 e il 1675. È divisa in sei parti, le prime cinque delle quali
trattano delle cause dei nostri errori:
1. i sensi, che ci sono stati dati solo per la conservazione del corpo e ai quali noi
chiediamo a torto la verità; 2. l’immaginazione, che interpone i suoi fantasmi fra la
nostra attenzione e la verità dell’idea; 3. l’intelletto, che non sa mantenere tesa
l’attenzione quanto sarebbe necessario; 4. le inclinazioni, che fanno deviare verso i
beni particolari la tendenza innata al bene universale; 5. le passioni, che turbano la
purezza dell’idea. Nella parte finale l’autore sviluppa la sua concezione
dell’occasionalismo* e la teoria della conoscenza come visione delle cose in Dio.
L’identificazione della filosofia con la teologia e l’affermazione della superiorità
dell’intelligenza sulla fede furono attaccate dall’Arnauld e dal Bossuet. L’opera va
considerata come un ripensamento del cartesianismo alla luce di preoccupazioni
prevalentemente apologetico-religiose.
Ricordi o Pensieri (Tà eis heautón: Le cose [dette] a se stesso), opera
dell’imperatore Marco Aurello (Roma 121 - Vindobona [Vienna] o Sirmio 180),
scritta in greco e pervenutaci divisa in dodici libri. È una raccolta di massime e di
riflessioni annotate di giorno in giorno. L’opera non ha perciò nessuna pretesa
sistematica e riflette una personale valutazione dei vari casi della vita. fatta con i
criteri forniti dall’etica cinicostoica. L’aspetto più caratteristico è costituito
dall’alternarsi di momenti pessimistici e scettici con altri animati invece da una
fervida fede nella provvidenza divina e da una profonda compassione per le
sofferenze degli uomini. È per quest’ultimo aspetto che Tertulliano riconobbe in
Marco Aurelio un’anima « naturalmente cristiana ». La data di composizione è
incerta, ma è molto probabile che Marco Aurelio abbia redatto questa sorta di diario