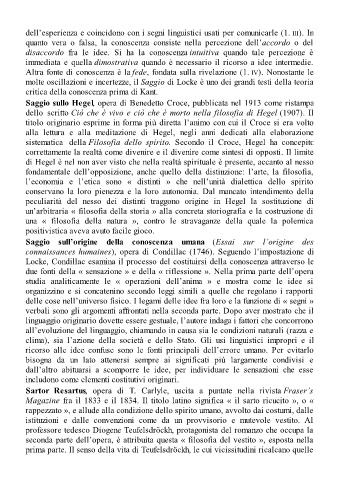Page 957 - Dizionario di Filosofia
P. 957
dell’esperienza e coincidono con i segni linguistici usati per comunicarle (1. III). In
quanto vera o falsa, la conoscenza consiste nella percezione dell’accordo o del
disaccordo fra le idee. Si ha la conoscenza intuitiva quando tale percezione è
immediata e quella dimostrativa quando è necessario il ricorso a idee intermedie.
Altra fonte di conoscenza è la fede, fondata sulla rivelazione (1. IV). Nonostante le
molte oscillazioni e incertezze, il Saggio di Locke è uno dei grandi testi della teoria
critica della conoscenza prima di Kant.
Saggio sullo Hegel, opera di Benedetto Croce, pubblicata nel 1913 come ristampa
dello scritto Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Hegel (1907). Il
titolo originario esprime in forma più diretta l’animo con cui il Croce si era volto
alla lettura e alla meditazione di Hegel, negli anni dedicati alla elaborazione
sistematica della Filosofia dello spirito. Secondo il Croce, Hegel ha concepito
correttamente la realtà come divenire e il divenire come sintesi di opposti. Il limite
di Hegel è nel non aver visto che nella realtà spirituale è presente, accanto al nesso
fondamentale dell’opposizione, anche quello della distinzione: l’arte, la filosofia,
l’economia e l’etica sono « distinti » che nell’unità dialettica dello spirito
conservano la loro pienezza e la loro autonomia. Dal mancato intendimento della
peculiarità del nesso dei distinti traggono origine in Hegel la sostituzione di
un’arbitraria « filosofia della storia » alla concreta storiografia e la costruzione di
una « filosofia della natura », contro le stravaganze della quale la polemica
positivistica aveva avuto facile gioco.
Saggio sull’origine della conoscenza umana (Essai sur l’origine des
connaissances humaines), opera di Condillac (1746). Seguendo l’impostazione di
Locke, Condillac esamina il processo del costituirsi della conoscenza attraverso le
due fonti della « sensazione » e della « riflessione ». Nella prima parte dell’opera
studia analiticamente le « operazioni dell’anima » e mostra come le idee si
organizzino e si concatenino secondo leggi simili a quelle che regolano i rapporti
delle cose nell’universo fisico. I legami delle idee fra loro e la funzione di « segni »
verbali sono gli argomenti affrontati nella seconda parte. Dopo aver mostrato che il
linguaggio originario dovette essere gestuale, l’autore indaga i fattori che concorrono
all’evoluzione del linguaggio, chiamando in causa sia le condizioni naturali (razza e
clima), sia l’azione della società e dello Stato. Gli usi linguistici impropri e il
ricorso alle idee confuse sono le fonti principali dell’errore umano. Per evitarlo
bisogna da un lato attenersi sempre ai significati più largamente condivisi e
dall’altro abituarsi a scomporre le idee, per individuare le sensazioni che esse
includono come elementi costitutivi originari.
Sartor Resartus, opera di T. Carlyle, uscita a puntate nella rivista Fraser’s
Magazine fra il 1833 e il 1834. Il titolo latino significa « il sarto ricucito », o «
rappezzato », e allude alla condizione dello spirito umano, avvolto dai costumi, dalle
istituzioni e dalle convenzioni come da un provvisorio e mutevole vestito. Al
professore tedesco Diogene Teufelsdröckh, protagonista del romanzo che occupa la
seconda parte dell’opera, è attribuita questa « filosofia del vestito », esposta nella
prima parte. Il senso della vita di Teufelsdröckh, le cui vicissitudini ricalcano quelle