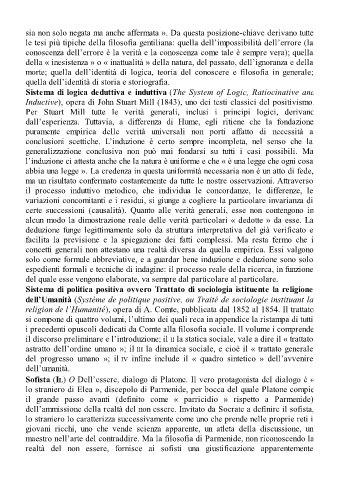Page 960 - Dizionario di Filosofia
P. 960
sia non solo negata ma anche affermata ». Da questa posizione-chiave derivano tutte
le tesi più tipiche della filosofia gentiliana: quella dell’impossibilità dell’errore (la
conoscenza dell’errore è la verità e la conoscenza come tale è sempre vera); quella
della « inesistenza » o « inattualità » della natura, del passato, dell’ignoranza e della
morte; quella dell’identità di logica, teoria del conoscere e filosofia in generale;
quella dell’identità di storia e storiografia.
Sistema di logica deduttiva e induttiva (The System of Logic, Ratiocinative and
Inductive), opera di John Stuart Mill (1843), uno dei testi classici del positivismo.
Per Stuart Mill tutte le verità generali, inclusi i principi logici, derivano
dall’esperienza. Tuttavia, a differenza di Hume, egli ritiene che la fondazione
puramente empirica delle verità universali non porti affatto di necessità a
conclusioni scettiche. L’induzione è certo sempre incompleta, nel senso che la
generalizzazione conclusiva non può mai fondarsi su tutti i casi possibili. Ma
l’induzione ci attesta anche che la natura è uniforme e che « è una legge che ogni cosa
abbia una legge ». La credenza in questa uniformità necessaria non è un atto di fede,
ma un risultato confermato costantemente da tutte le nostre osservazioni. Attraverso
il processo induttivo metodico, che individua le concordanze, le differenze, le
variazioni concomitanti e i residui, si giunge a cogliere la particolare invarianza di
certe successioni (causalità). Quanto alle verità generali, esse non contengono in
alcun modo la dimostrazione reale delle verità particolari « dedotte » da esse. La
deduzione funge legittimamente solo da struttura interpretativa del già verificato e
facilita la previsione e la spiegazione dei fatti complessi. Ma resta fermo che i
concetti generali non attestano una realtà diversa da quella empirica. Essi valgono
solo come formule abbreviative, e a guardar bene induzione e deduzione sono solo
espedienti formali e tecniche di indagine: il processo reale della ricerca, in funzione
del quale esse vengono elaborate, va sempre dal particolare al particolare.
Sistema di politica positiva ovvero Trattato di sociologia istituente la religione
dell’Umanità (Système de politique positive, ou Traité de sociologie instituant la
religion de l’Humanité), opera di A. Comte, pubblicata dal 1852 al 1854. Il trattato
si compone di quattro volumi, l’ultimo dei quali reca in appendice la ristampa di tutti
i precedenti opuscoli dedicati da Comte alla filosofia sociale. Il volume i comprende
il discorso preliminare e l’introduzione; il II la statica sociale, vale a dire il « trattato
astratto dell’ordine umano »; il III la dinamica sociale, e cioè il « trattato generale
del progresso umano »; il IV infine include il « quadro sintetico » dell’avvenire
dell’umanità.
Sofista (IL) O Dell’essere, dialogo di Platone. Il vero protagonista del dialogo è «
lo straniero di Elea », discepolo di Parmenide, per bocca del quale Platone compie
il grande passo avanti (definito come « parricidio » rispetto a Parmenide)
dell’ammissione della realtà del non essere. Invitato da Socrate a definire il sofista,
lo straniero lo caratterizza successivamente come uno che prende nelle proprie reti i
giovani ricchi, uno che vende scienza apparente, un atleta della discussione, un
maestro nell’arte del contraddire. Ma la filosofia di Parmenide, non riconoscendo la
realtà del non essere, fornisce ai sofisti una giustificazione apparentemente