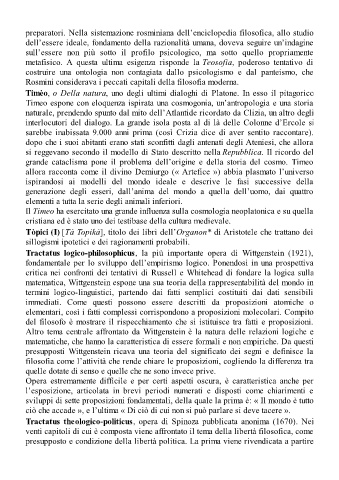Page 965 - Dizionario di Filosofia
P. 965
preparatori. Nella sistemazione rosminiana dell’enciclopedia filosofica, allo studio
dell’essere ideale, fondamento della razionalità umana, doveva seguire un’indagine
sull’essere non più sotto il profilo psicologico, ma sotto quello propriamente
metafisico. A questa ultima esigenza risponde la Teosofia, poderoso tentativo di
costruire una ontologia non contagiata dallo psicologismo e dal panteismo, che
Rosmini considerava i peccati capitali della filosofia moderna.
Timèo, o Della natura, uno degli ultimi dialoghi di Platone. In esso il pitagorico
Timeo espone con eloquenza ispirata una cosmogonia, un’antropologia e una storia
naturale, prendendo spunto dal mito dell’Atlantide ricordato da Clizia, un altro degli
interlocutori del dialogo. La grande isola posta al di là delle Colonne d’Ercole si
sarebbe inabissata 9.000 anni prima (così Crizia dice di aver sentito raccontare).
dopo che i suoi abitanti erano stati sconfitti dagli antenati degli Ateniesi, che allora
si reggevano secondo il modello di Stato descritto nella Repubblica. Il ricordo del
grande cataclisma pone il problema dell’origine e della storia del cosmo. Timeo
allora racconta come il divino Demiurgo (« Artefice ») abbia plasmato l’universo
ispirandosi ai modelli del mondo ideale e descrive le fasi successive della
generazione degli esseri, dall’anima del mondo a quella dell’uomo, dai quattro
elementi a tutta la serie degli animali inferiori.
Il Timeo ha esercitato una grande influenza sulla cosmologia neoplatonica e su quella
cristiana ed è stato uno dei testibase della cultura medievale.
Tòpici (I) [Tà Topikà], titolo dei libri dell’Organon* di Aristotele che trattano dei
sillogismi ipotetici e dei ragionamenti probabili.
Tractatus logico-philosophicus, la più importante opera di Wittgenstein (1921),
fondamentale per lo sviluppo dell’empirismo logico. Ponendosi in una prospettiva
critica nei confronti dei tentativi di Russell e Whitehead di fondare la logica sulla
matematica, Wittgenstein espone una sua teoria della rappresentabilità del mondo in
termini logico-linguistici, partendo dai fatti semplici costituiti dai dati sensibili
immediati. Come questi possono essere descritti da proposizioni atomiche o
elementari, così i fatti complessi corrispondono a proposizioni molecolari. Compito
del filosofo è mostrare il rispecchiamento che si istituisce tra fatti e proposizioni.
Altro tema centrale affrontato da Wittgenstein è la natura delle relazioni logiche e
matematiche, che hanno la caratteristica di essere formali e non empiriche. Da questi
presupposti Wittgenstein ricava una teoria del significato dei segni e definisce la
filosofia come l’attività che rende chiare le proposizioni, cogliendo la differenza tra
quelle dotate di senso e quelle che ne sono invece prive.
Opera estremamente difficile e per certi aspetti oscura, è caratteristica anche per
l’esposizione, articolata in brevi periodi numerati e disposti come chiarimenti e
sviluppi di sette proposizioni fondamentali, della quale la prima è: « Il mondo è tutto
ciò che accade », e l’ultima « Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere ».
Tractatus theologico-politicus, opera di Spinoza pubblicata anonima (1670). Nei
venti capitoli di cui è composta viene affrontato il tema della libertà filosofica, come
presupposto e condizione della libertà politica. La prima viene rivendicata a partire