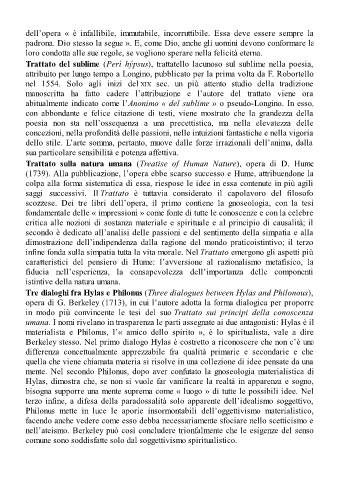Page 967 - Dizionario di Filosofia
P. 967
dell’opera « è infallibile, immutabile, incorruttibile. Essa deve essere sempre la
padrona. Dio stesso la segue ». E, come Dio, anche gli uomini devono conformare la
loro condotta alle sue regole, se vogliono sperare nella felicità eterna.
Trattato del sublime (Perì hýpsus), trattatello lacunoso sul sublime nella poesia,
attribuito per lungo tempo a Longino, pubblicato per la prima volta da F. Robortello
nel 1554. Solo agli inizi del XIX sec. un più attento studio della tradizione
manoscritta ha fatto cadere l’attribuzione e l’autore del trattato viene ora
abitualmente indicato come l’Anonimo « del sublime » o pseudo-Longino. In esso,
con abbondante e felice citazione di testi, viene mostrato che la grandezza della
poesia non sta nell’ossequenza a una precettistica, ma nella elevatezza delle
concezioni, nella profondità delle passioni, nelle intuizioni fantastiche e nella vigoria
dello stile. L’arte somma, pertanto, muove dalle forze irrazionali dell’anima, dalla
sua particolare sensibilità e potenza affettiva.
Trattato sulla natura umana (Treatise of Human Nature), opera di D. Hume
(1739). Alla pubblicazione, l’opera ebbe scarso successo e Hume, attribuendone la
colpa alla forma sistematica di essa, riespose le idee in essa contenute in più agili
saggi successivi. Il Trattato è tuttavia considerato il capolavoro del filosofo
scozzese. Dei tre libri dell’opera, il primo contiene la gnoseologia, con la tesi
fondamentale delle « impressioni » come fonte di tutte le conoscenze e con la celebre
critica alle nozioni di sostanza materiale e spirituale e al principio di causalità; il
secondo è dedicato all’analisi delle passioni e del sentimento della simpatia e alla
dimostrazione dell’indipendenza dalla ragione del mondo praticoistintivo; il terzo
infine fonda sulla simpatia tutta la vita morale. Nel Trattato emergono gli aspetti più
caratteristici del pensiero di Hume: l’avversione al razionalismo metafisico, la
fiducia nell’esperienza, la consapevolezza dell’importanza delle componenti
istintive della natura umana.
Tre dialoghi fra Hylas e Philonus (Three dialogues between Hylas and Philonous),
opera di G. Berkeley (1713), in cui l’autore adotta la forma dialogica per proporre
in modo più convincente le tesi del suo Trattato sui principi della conoscenza
umana. I nomi rivelano in trasparenza le parti assegnate ai due antagonisti: Hylas è il
materialista e Philonus, l’« amico dello spirito », è lo spiritualista, vale a dire
Berkeley stesso. Nel primo dialogo Hylas è costretto a riconoscere che non c’è una
differenza concettualmente apprezzabile fra qualità primarie e secondarie e che
quella che viene chiamata materia si risolve in una collezione di idee pensate da una
mente. Nel secondo Philonus, dopo aver confutato la gnoseologia materialistica di
Hylas, dimostra che, se non si vuole far vanificare la realtà in apparenza e sogno,
bisogna supporre una mente suprema come « luogo » di tutte le possibili idee. Nel
terzo infine, a difesa della paradossalità solo apparente dell’idealismo soggettivo,
Philonus mette in luce le aporie insormontabili dell’oggettivismo materialistico,
facendo anche vedere come esso debba necessariamente sfociare nello scetticismo e
nell’ateismo. Berkeley può così concludere trionfalmente che le esigenze del senso
comune sono soddisfatte solo dal soggettivismo spiritualistico.