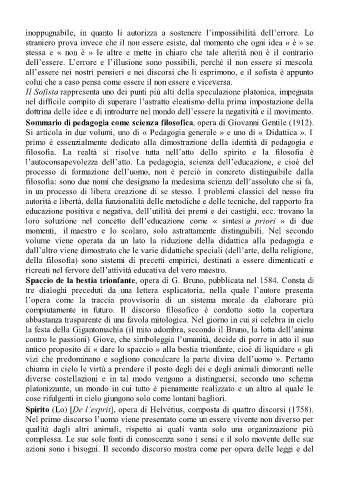Page 961 - Dizionario di Filosofia
P. 961
inoppugnabile, in quanto li autorizza a sostenere l’impossibilità dell’errore. Lo
straniero prova invece che il non essere esiste, dal momento che ogni idea « è » se
stessa e « non è » le altre e mette in chiaro che tale alterità non è il contrario
dell’essere. L’errore e l’illusione sono possibili, perché il non essere si mescola
all’essere nei nostri pensieri e nei discorsi che li esprimono, e il sofista è appunto
colui che a caso pensa come essere il non essere e viceversa.
Il Sofista rappresenta uno dei punti più alti della speculazione platonica, impegnata
nel diffìcile compito di superare l’astratto eleatismo della prima impostazione della
dottrina delle idee e di introdurre nel mondo dell’essere la negatività e il movimento.
Sommario di pedagogia come scienza filosofica, opera di Giovanni Gentile (1912).
Si articola in due volumi, uno di « Pedagogia generale » e uno di « Didattica ». Il
primo è essenzialmente dedicato alla dimostrazione della identità di pedagogia e
filosofia. La realtà si risolve tutta nell’atto dello spirito e la filosofia è
l’autoconsapevolezza dell’atto. La pedagogia, scienza dell’educazione, e cioè del
processo di formazione dell’uomo, non è perciò in concreto distinguibile dalla
filosofia: sono due nomi che designano la medesima scienza dell’assoluto che si fa,
in un processo di libera creazione di se stesso. I problemi classici del nesso fra
autorità e libertà, della funzionalità delle metodiche e delle tecniche, del rapporto fra
educazione positiva e negativa, dell’utilità dei premi e dei castighi, ecc. trovano la
loro soluzione nel concetto dell’educazione come « sintesi a priori » di due
momenti, il maestro e lo scolaro, solo astrattamente distinguibili. Nel secondo
volume viene operata da un lato la riduzione della didattica alla pedagogia e
dall’altro viene dimostrato che le varie didattiche speciali (dell’arte, della religione,
della filosofìa) sono sistemi di precetti empirici, destinati a essere dimenticati e
ricreati nel fervore dell’attività educativa del vero maestro.
Spaccio de la bestia trionfante, opera di G. Bruno, pubblicata nel 1584. Consta di
tre dialoghi preceduti da una lettera esplicatoria, nella quale l’autore presenta
l’opera come la traccia provvisoria di un sistema morale da elaborare più
compiutamente in futuro. Il discorso filosofico è condotto sotto la copertura
abbastanza trasparente di una favola mitologica. Nel giorno in cui si celebra in cielo
la festa della Gigantomachia (il mito adombra, secondo il Bruno, la lotta dell’anima
contro le passioni) Giove, che simboleggia l’umanità, decide di porre in atto il suo
antico proposito di « dare lo spaccio » alla bestia trionfante, cioè di liquidare « gli
vizi che predominano e sogliono conculcare la parte divina dell’uomo ». Pertanto
chiama in cielo le virtù a prendere il posto degli dei e degli animali dimoranti nelle
diverse costellazioni e in tal modo vengono a distinguersi, secondo uno schema
platonizzante, un mondo in cui tutto è pienamente realizzato e un altro al quale le
cose rifulgenti in cielo giungono solo come lontani bagliori.
Spirito (Lo) [De l’esprit], opera di Helvétius, composta di quattro discorsi (1758).
Nel primo discorso l’uomo viene presentato come un essere vivente non diverso per
qualità dagli altri animali, rispetto ai quali vanta solo una organizzazione più
complessa. Le sue sole fonti di conoscenza sono i sensi e il solo movente delle sue
azioni sono i bisogni. Il secondo discorso mostra come per opera delle leggi e del