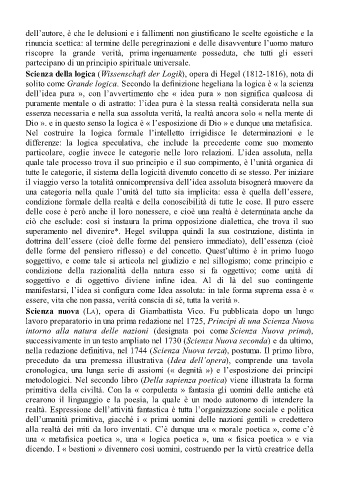Page 958 - Dizionario di Filosofia
P. 958
dell’autore, è che le delusioni e i fallimenti non giustificano le scelte egoistiche e la
rinuncia scettica: al termine delle peregrinazioni e delle disavventure l’uomo maturo
riscopre la grande verità, prima ingenuamente posseduta, che tutti gli esseri
partecipano di un principio spirituale universale.
Scienza della logica (Wissenschaft der Logik), opera di Hegel (1812-1816), nota di
solito come Grande logica. Secondo la definizione hegeliana la logica è « la scienza
dell’idea pura », con l’avvertimento che « idea pura » non significa qualcosa di
puramente mentale o di astratto: l’idea pura è la stessa realtà considerata nella sua
essenza necessaria e nella sua assoluta verità, la realtà ancora solo « nella mente di
Dio ». e in questo senso la logica è « l’esposizione di Dio » e dunque una metafisica.
Nel costruire la logica formale l’intelletto irrigidisce le determinazioni e le
differenze: la logica speculativa, che include la precedente come suo momento
particolare, coglie invece le categorie nelle loro relazioni. L’idea assoluta, nella
quale tale processo trova il suo principio e il suo compimento, è l’unità organica di
tutte le categorie, il sistema della logicità divenuto concetto di se stesso. Per iniziare
il viaggio verso la totalità onnicomprensiva dell’idea assoluta bisognerà muovere da
una categoria nella quale l’unità del tutto sia implicita: essa è quella dell’essere,
condizione formale della realtà e della conoscibilità di tutte le cose. Il puro essere
delle cose è però anche il loro nonessere, e cioè una realtà è determinata anche da
ciò che esclude: così si instaura la prima opposizione dialettica, che trova il suo
superamento nel divenire*. Hegel sviluppa quindi la sua costruzione, distinta in
dottrina dell’essere (cioè delle forme del pensiero immediato), dell’essenza (cioè
delle forme del pensiero riflesso) e del concetto. Quest’ultimo è in primo luogo
soggettivo, e come tale si articola nel giudizio e nel sillogismo; come principio e
condizione della razionalità della natura esso si fa oggettivo; come unità di
soggettivo e di oggettivo diviene infine idea. Al di là del suo contingente
manifestarsi, l’idea si configura come Idea assoluta: in tale forma suprema essa è «
essere, vita che non passa, verità conscia di sé, tutta la verità ».
Scienza nuova (LA), opera di Giambattista Vico. Fu pubblicata dopo un lungo
lavoro preparatorio in una prima redazione nel 1725, Principi di una Scienza Nuova
intorno alla natura delle nazioni (designata poi come Scienza Nuova prima),
successivamente in un testo ampliato nel 1730 (Scienza Nuova seconda) e da ultimo,
nella redazione definitiva, nel 1744 (Scienza Nuova terza), postuma. Il primo libro,
preceduto da una premessa illustrativa (Idea dell’opera), comprende una tavola
cronologica, una lunga serie di assiomi (« degnità ») e l’esposizione dei principi
metodologici. Nel secondo libro (Della sapienza poetica) viene illustrata la forma
primitiva della civiltà. Con la « corpulenta » fantasia gli uomini delle antiche età
crearono il linguaggio e la poesia, la quale è un modo autonomo di intendere la
realtà. Espressione dell’attività fantastica è tutta l’organizzazione sociale e politica
dell’umanità primitiva, giacché i « primi uomini delle nazioni gentili » credettero
alla realtà dei miti da loro inventati. C’è dunque una « morale poetica », come c’è
una « metafisica poetica », una « logica poetica », una « fisica poetica » e via
dicendo. I « bestioni » divennero così uomini, costruendo per la virtù creatrice della