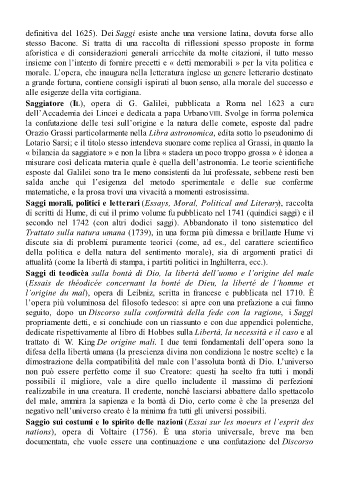Page 955 - Dizionario di Filosofia
P. 955
definitiva del 1625). Dei Saggi esiste anche una versione latina, dovuta forse allo
stesso Bacone. Si tratta di una raccolta di riflessioni spesso proposte in forma
aforistica e di considerazioni generali arricchite da molte citazioni, il tutto messo
insieme con l’intento di fornire precetti e « detti memorabili » per la vita politica e
morale. L’opera, che inaugura nella letteratura inglese un genere letterario destinato
a grande fortuna, contiene consigli ispirati al buon senso, alla morale del successo e
alle esigenze della vita cortigiana.
Saggiatore (IL), opera di G. Galilei, pubblicata a Roma nel 1623 a cura
dell’Accademia dei Lincei e dedicata a papa Urbano VIII. Svolge in forma polemica
la confutazione delle tesi sull’origine e la natura delle comete, esposte dal padre
Orazio Grassi particolarmente nella Libra astronomica, edita sotto lo pseudonimo di
Lotario Sarsi; e il titolo stesso intendeva suonare come replica al Grassi, in quanto la
« bilancia da saggiatore » e non la libra « stadera un poco troppo grossa » è idonea a
misurare così delicata materia quale è quella dell’astronomia. Le teorie scientifiche
esposte dal Galilei sono tra le meno consistenti da lui professate, sebbene resti ben
salda anche qui l’esigenza del metodo sperimentale e delle sue conferme
matematiche, e la prosa trovi una vivacità a momenti estrosissima.
Saggi morali, politici e letterari (Essays, Moral, Political and Literary), raccolta
di scritti di Hume, di cui il primo volume fu pubblicato nel 1741 (quindici saggi) e il
secondo nel 1742 (con altri dodici saggi). Abbandonato il tono sistematico del
Trattato sulla natura umana (1739), in una forma più dimessa e brillante Hume vi
discute sia di problemi puramente teorici (come, ad es., del carattere scientifico
della politica e della natura del sentimento morale), sia di argomenti pratici di
attualità (come la libertà di stampa, i partiti politici in Inghilterra, ecc.).
Saggi di teodicèa sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male
(Essais de théodicée concernant la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et
l’origine du mal), opera di Leibniz, scritta in francese e pubblicata nel 1710. È
l’opera più voluminosa del filosofo tedesco: si apre con una prefazione a cui fanno
seguito, dopo un Discorso sulla conformità della fede con la ragione, i Saggi
propriamente detti, e si conchiude con un riassunto e con due appendici polemiche,
dedicate rispettivamente al libro di Hobbes sulla Libertà, la necessità e il caso e al
trattato di W. King De origine mali. I due temi fondamentali dell’opera sono la
difesa della libertà umana (la prescienza divina non condiziona le nostre scelte) e la
dimostrazione della compatibilità del male con l’assoluta bontà di Dio. L’universo
non può essere perfetto come il suo Creatore: questi ha scelto fra tutti i mondi
possibili il migliore, vale a dire quello includente il massimo di perfezioni
realizzabile in una creatura. Il credente, nonché lasciarsi abbattere dallo spettacolo
del male, ammira la sapienza e la bontà di Dio, certo come è che la presenza del
negativo nell’universo creato è la minima fra tutti gli universi possibili.
Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni (Essai sur les moeurs et l’esprit des
nations), opera di Voltaire (1756). È una storia universale, breve ma ben
documentata, che vuole essere una continuazione e una confutazione del Discorso