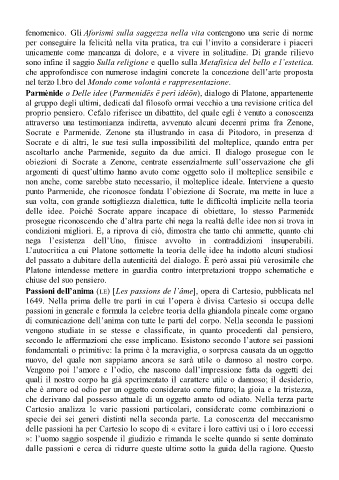Page 944 - Dizionario di Filosofia
P. 944
fenomenico. Gli Aforismi sulla saggezza nella vita contengono una serie di norme
per conseguire la felicità nella vita pratica, tra cui l’invito a considerare i piaceri
unicamente come mancanza di dolore, e a vivere in solitudine. Di grande rilievo
sono infine il saggio Sulla religione e quello sulla Metafisica del bello e l’estetica.
che approfondisce con numerose indagini concrete la concezione dell’arte proposta
nel terzo l.bro del Mondo come volontà e rappresentazione.
Parmènide o Delle idee (Parmenidēs ē perì idéōn), dialogo di Platone, appartenente
al gruppo degli ultimi, dedicati dal filosofo ormai vecchio a una revisione critica del
proprio pensiero. Cefalo riferisce un dibattito, del quale egli è venuto a conoscenza
attraverso una testimonianza indiretta, avvenuto alcuni decenni prima fra Zenone,
Socrate e Parmenide. Zenone sta illustrando in casa di Pitodoro, in presenza di
Socrate e di altri, le sue tesi sulla impossibilità del molteplice, quando entra per
ascoltarlo anche Parmenide, seguito da due amici. Il dialogo prosegue con le
obiezioni di Socrate a Zenone, centrate essenzialmente sull’osservazione che gli
argomenti di quest’ultimo hanno avuto come oggetto solo il molteplice sensibile e
non anche, come sarebbe stato necessario, il molteplice ideale. Interviene a questo
punto Parmenide, che riconosce fondata l’obiezione di Socrate, ma mette in luce a
sua volta, con grande sottigliezza dialettica, tutte le difficoltà implicite nella teoria
delle idee. Poiché Socrate appare incapace di obiettare, lo stesso Parmenide
prosegue riconoscendo che d’altra parte chi nega la realtà delle idee non si trova in
condizioni migliori. E, a riprova di ciò, dimostra che tanto chi ammette, quanto chi
nega l’esistenza dell’Uno, finisce avvolto in contraddizioni insuperabili.
L’autocritica a cui Platone sottomette la teoria delle idee ha indotto alcuni studiosi
del passato a dubitare della autenticità del dialogo. È però assai più verosimile che
Platone intendesse mettere in guardia contro interpretazioni troppo schematiche e
chiuse del suo pensiero.
Passioni dell’anima (LE) [Les passions de l’âme], opera di Cartesio, pubblicata nel
1649. Nella prima delle tre parti in cui l’opera è divisa Cartesio si occupa delle
passioni in generale e formula la celebre teoria della ghiandola pineale come organo
di comunicazione dell’anima con tutte le parti del corpo. Nella seconda le passioni
vengono studiate in se stesse e classificate, in quanto procedenti dal pensiero,
secondo le affermazioni che esse implicano. Esistono secondo l’autore sei passioni
fondamentali o primitive: la prima è la meraviglia, o sorpresa causata da un oggetto
nuovo, del quale non sappiamo ancora se sarà utile o dannoso al nostro corpo.
Vengono poi l’amore e l’odio, che nascono dall’impressione fatta da oggetti dei
quali il nostro corpo ha già sperimentato il carattere utile o dannoso; il desiderio,
che è amore od odio per un oggetto considerato come futuro; la gioia e la tristezza,
che derivano dal possesso attuale di un oggetto amato od odiato. Nella terza parte
Cartesio analizza le varie passioni particolari, considerate come combinazioni o
specie dei sei generi distinti nella seconda parte. La conoscenza del meccanismo
delle passioni ha per Cartesio lo scopo di « evitare i loro cattivi usi o i loro eccessi
»: l’uomo saggio sospende il giudizio e rimanda le scelte quando si sente dominato
dalle passioni e cerca di ridurre queste ultime sotto la guida della ragione. Questo