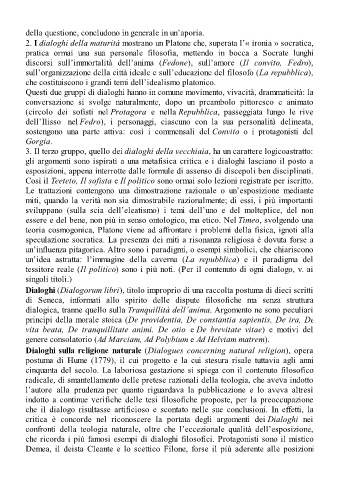Page 908 - Dizionario di Filosofia
P. 908
della questione, concludono in generale in un’aporia.
2. I dialoghi della maturità mostrano un Platone che, superata l’« ironia » socratica,
pratica ormai una sua personale filosofia, mettendo in bocca a Socrate lunghi
discorsi sull’immortalità dell’anima (Fedone), sull’amore (Il convito, Fedro),
sull’organizzazione della città ideale e sull’educazione del filosofo (La repubblica),
che costituiscono i grandi temi dell’idealismo platonico.
Questi due gruppi di dialoghi hanno in comune movimento, vivacità, drammaticità: la
conversazione si svolge naturalmente, dopo un preambolo pittoresco e animato
(circolo dei sofisti nel Protagora e nella Repubblica, passeggiata lungo le rive
dell’Ilisso nel Fedro), i personaggi, ciascuno con la sua personalità delineata,
sostengono una parte attiva: così i commensali del Convito o i protagonisti del
Gorgia.
3. Il terzo gruppo, quello dei dialoghi della vecchiaia, ha un carattere logicoastratto:
gli argomenti sono ispirati a una metafisica critica e i dialoghi lasciano il posto a
esposizioni, appena interrotte dalle formule di assenso di discepoli ben disciplinati.
Così il Teeteto, Il sofista e Il politico sono ormai solo lezioni registrate per iscritto.
Le trattazioni contengono una dimostrazione razionale o un’esposizione mediante
miti, quando la verità non sia dimostrabile razionalmente; di essi, i più importanti
sviluppano (sulla scia dell’eleatismo) i temi dell’uno e del molteplice, del non
essere e del bene, non più in senso ontologico, ma etico. Nel Timeo, svolgendo una
teoria cosmogonica, Platone viene ad affrontare i problemi della fisica, ignoti alla
speculazione socratica. La presenza dei miti a risonanza religiosa è dovuta forse a
un’influenza pitagorica. Altro sono i paradigmi, o esempi simbolici, che chiariscono
un’idea astratta: l’immagine della caverna (La repubblica) e il paradigma del
tessitore reale (Il politico) sono i più noti. (Per il contenuto di ogni dialogo, v. ai
singoli titoli.)
Dialoghi (Dialogorum libri), titolo improprio di una raccolta postuma di dieci scritti
di Seneca, informati allo spirito delle dispute filosofiche ma senza struttura
dialogica, tranne quello sulla Tranquillità dell’anima. Argomento ne sono peculiari
principi della morale stoica (De providentia, De constantia sapientis, De ira, De
vita beata, De tranquillitate animi. De otio e De brevitate vitae) e motivi del
genere consolatorio (Ad Marciam, Ad Polybium e Ad Helviam matrem).
Dialoghi sulla religione naturale (Dialogues concerning natural religion), opera
postuma di Hume (1779), il cui progetto e la cui stesura risale tuttavia agli anni
cinquanta del secolo. La laboriosa gestazione si spiega con il contenuto filosofico
radicale, di smantellamento delle pretese razionali della teologia, che aveva indotto
l’autore alla prudenza per quanto riguardava la pubblicazione e lo aveva altresì
indotto a continue verifiche delle tesi filosofiche proposte, per la preoccupazione
che il dialogo risultasse artificioso e scontato nelle sue conclusioni. In effetti, la
critica è concorde nel riconoscere la portata degli argomenti dei Dialoghi nei
confronti della teologia naturale, oltre che l’eccezionale qualità dell’esposizione,
che ricorda i più famosi esempi di dialoghi filosofici. Protagonisti sono il mistico
Demea, il deista Cleante e lo scettico Filone, forse il più aderente alle posizioni