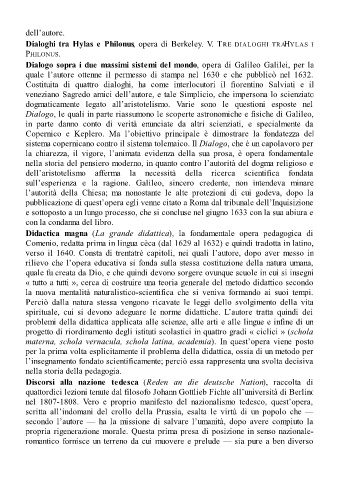Page 909 - Dizionario di Filosofia
P. 909
dell’autore.
Dialoghi tra Hylas e Philonus, opera di Berkeley. V. TRE DIALOGHI TRA HYLAS E
PHILONUS.
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, opera di Galileo Galilei, per la
quale l’autore ottenne il permesso di stampa nel 1630 e che pubblicò nel 1632.
Costituita di quattro dialoghi, ha come interlocutori il fiorentino Salviati e il
veneziano Sagredo amici dell’autore, e tale Simplicio, che impersona lo scienziato
dogmaticamente legato all’aristotelismo. Varie sono le questioni esposte nel
Dialogo, le quali in parte riassumono le scoperte astronomiche e fisiche di Galileo,
in parte danno conto di verità enunciate da altri scienziati, e specialmente da
Copernico e Keplero. Ma l’obiettivo principale è dimostrare la fondatezza del
sistema copernicano contro il sistema tolemaico. Il Dialogo, che è un capolavoro per
la chiarezza, il vigore, l’animata evidenza della sua prosa, è opera fondamentale
nella storia del pensiero moderno, in quanto contro l’autorità del dogma religioso e
dell’aristotelismo afferma la necessità della ricerca scientifica fondata
sull’esperienza e la ragione. Galileo, sincero credente, non intendeva minare
l’autorità della Chiesa; ma nonostante le alte protezioni di cui godeva, dopo la
pubblicazione di quest’opera egli venne citato a Roma dal tribunale dell’Inquisizione
e sottoposto a un lungo processo, che si concluse nel giugno 1633 con la sua abiura e
con la condanna del libro.
Didactica magna (La grande didattica), la fondamentale opera pedagogica di
Comenio, redatta prima in lingua cèca (dal 1629 al 1632) e quindi tradotta in latino,
verso il 1640. Consta di trentatré capitoli, nei quali l’autore, dopo aver messo in
rilievo che l’opera educativa si fonda sulla stessa costituzione della natura umana,
quale fu creata da Dio, e che quindi devono sorgere ovunque scuole in cui si insegni
« tutto a tutti », cerca di costruire una teoria generale del metodo didattico secondo
la nuova mentalità naturalistico-scientifica che si veniva formando ai suoi tempi.
Perciò dalla natura stessa vengono ricavate le leggi dello svolgimento della vita
spirituale, cui si devono adeguare le norme didattiche. L’autore tratta quindi dei
problemi della didattica applicata alle scienze, alle arti e alle lingue e infine di un
progetto di riordinamento degli istituti scolastici in quattro gradi « ciclici » (schola
materna, schola vernacula, schola latina, academia). In quest’opera viene posto
per la prima volta esplicitamente il problema della didattica, ossia di un metodo per
l’insegnamento fondato scientificamente; perciò essa rappresenta una svolta decisiva
nella storia della pedagogia.
Discorsi alla nazione tedesca (Reden an die deutsche Nation), raccolta di
quattordici lezioni tenute dal filosofo Johann Gottlieb Fichte all’università di Berlino
nel 1807-1808. Vero e proprio manifesto del nazionalismo tedesco, quest’opera,
scritta all’indomani del crollo della Prussia, esalta le virtù di un popolo che —
secondo l’autore — ha la missione di salvare l’umanità, dopo avere compiuto la
propria rigenerazione morale. Questa prima presa di posizione in senso nazionale-
romantico fornisce un terreno da cui muovere e prelude — sia pure a ben diverso