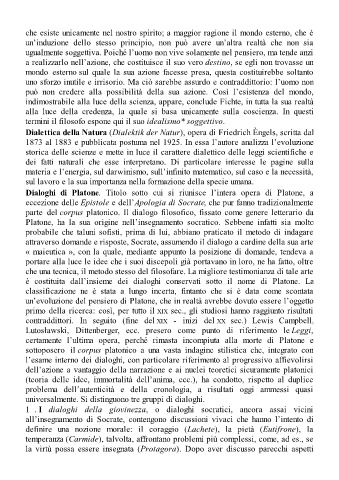Page 907 - Dizionario di Filosofia
P. 907
che esiste unicamente nel nostro spirito; a maggior ragione il mondo esterno, che è
un’induzione dello stesso principio, non può avere un’altra realtà che non sia
ugualmente soggettiva. Poiché l’uomo non vive solamente nel pensiero, ma tende anzi
a realizzarlo nell’azione, che costituisce il suo vero destino, se egli non trovasse un
mondo esterno sul quale la sua azione facesse presa, questa costituirebbe soltanto
uno sforzo inutile e irrisorio. Ma ciò sarebbe assurdo e contraddittorio: l’uomo non
può non credere alla possibilità della sua azione. Così l’esistenza del mondo,
indimostrabile alla luce della scienza, appare, conclude Fichte, in tutta la sua realtà
alla luce della credenza, la quale si basa unicamente sulla coscienza. In questi
termini il filosofo espone qui il suo idealismo* soggettivo.
Dialettica della Natura (Dialektik der Natur), opera di Friedrich Èngels, scritta dal
1873 al 1883 e pubblicata postuma nel 1925. In essa l’autore analizza l’evoluzione
storica delle scienze e mette in luce il carattere dialettico delle leggi scientifiche e
dei fatti naturali che esse interpretano. Di particolare interesse le pagine sulla
materia e l’energia, sul darwinismo, sull’infinito matematico, sul caso e la necessità,
sul lavoro e la sua importanza nella formazione della specie umana.
Dialoghi di Platone. Titolo sotto cui si riunisce l’intera opera di Platone, a
eccezione delle Epistole e dell’Apologia di Socrate, che pur fanno tradizionalmente
parte del corpus platonico. Il dialogo filosofico, fissato come genere letterario da
Platone, ha la sua origine nell’insegnamento socratico. Sebbene infatti sia molto
probabile che taluni sofisti, prima di lui, abbiano praticato il metodo di indagare
attraverso domande e risposte, Socrate, assumendo il dialogo a cardine della sua arte
« maieutica », con la quale, mediante appunto la posizione di domande, tendeva a
portare alla luce le idee che i suoi discepoli già portavano in loro, ne ha fatto, oltre
che una tecnica, il metodo stesso del filosofare. La migliore testimonianza di tale arte
è costituita dall’insieme dei dialoghi conservati sotto il nome di Platone. La
classificazione ne è stata a lungo incerta, fintanto che si è data come scontata
un’evoluzione del pensiero di Platone, che in realtà avrebbe dovuto essere l’oggetto
primo della ricerca: così, per tutto il XIX sec., gli studiosi hanno raggiunto risultati
contraddittori. In seguito (fine del XIX - inizi del XX sec.) Lewis Campbell,
Lutosławski, Dittenberger, ecc. presero come punto di riferimento le Leggi,
certamente l’ultima opera, perché rimasta incompiuta alla morte di Platone e
sottoposero il corpus platonico a una vasta indagine stilistica che, integrato con
l’esame interno dei dialoghi, con particolare riferimento al progressivo affievolirsi
dell’azione a vantaggio della narrazione e ai nuclei teoretici sicuramente platonici
(teoria delle idee, immortalità dell’anima, ecc.), ha condotto, rispetto al duplice
problema dell’autenticità e della cronologia, a risultati oggi ammessi quasi
universalmente. Si distinguono tre gruppi di dialoghi.
1 . I dialoghi della giovinezza, o dialoghi socratici, ancora assai vicini
all’insegnamento di Socrate, contengono discussioni vivaci che hanno l’intento di
definire una nozione morale: il coraggio (Lachete), la pietà (Eutifrone), la
temperanza (Carmide), talvolta, affrontano problemi più complessi, come, ad es., se
la virtù possa essere insegnata (Protagora). Dopo aver discusso parecchi aspetti