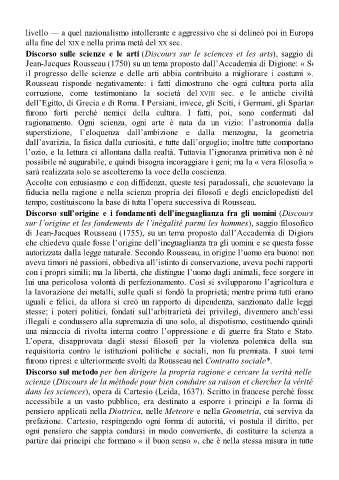Page 910 - Dizionario di Filosofia
P. 910
livello — a quel nazionalismo intollerante e aggressivo che si delineò poi in Europa
alla fine del XIX e nella prima metà del XX sec.
Discorso sulle scienze e le arti (Discours sur le sciences et les arts), saggio di
Jean-Jacques Rousseau (1750) su un tema proposto dall’Accademia di Digione: « Se
il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a migliorare i costumi ».
Rousseau risponde negativamente: i fatti dimostrano che ogni cultura porta alla
corruzione, come testimoniano la società del XVIII sec. e le antiche civiltà
dell’Egitto, di Grecia e di Roma. I Persiani, invece, gli Sciti, i Germani, gli Spartani
furono forti perché nemici della cultura. I fatti, poi, sono confermati dal
ragionamento. Ogni scienza, ogni arte è nata da un vizio: l’astronomia dalla
superstizione, l’eloquenza dall’ambizione e dalla menzogna, la geometria
dall’avarizia, la fisica dalla curiosità, e tutte dall’orgoglio; inoltre tutte comportano
l’ozio, e la lettura ci allontana dalla realtà. Tuttavia l’ignoranza primitiva non è né
possibile né augurabile, e quindi bisogna incoraggiare i geni; ma la « vera filosofia »
sarà realizzata solo se ascolteremo la voce della coscienza.
Accolte con entusiasmo e con diffidenza, queste tesi paradossali, che scuotevano la
fiducia nella ragione e nella scienza propria dei filosofi e degli enciclopedisti del
tempo, costituiscono la base di tutta l’opera successiva di Rousseau.
Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza fra gli uomini (Discours
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes), saggio filosofico
di Jean-Jacques Rousseau (1755), su un tema proposto dall’Accademia di Digione
che chiedeva quale fosse l’origine dell’ineguaglianza tra gli uomini e se questa fosse
autorizzata dalla legge naturale. Secondo Rousseau, in origine l’uomo era buono: non
aveva timori né passioni, obbediva all’istinto di conservazione, aveva pochi rapporti
con i propri simili; ma la libertà, che distingue l’uomo dagli animali, fece sorgere in
lui una pericolosa volontà di perfezionamento. Così si svilupparono l’agricoltura e
la lavorazione dei metalli, sulle quali si fondò la proprietà; mentre prima tutti erano
uguali e felici, da allora si creò un rapporto di dipendenza, sanzionato dalle leggi
stesse; i poteri politici, fondati sull’arbitrarietà dei privilegi, divennero anch’essi
illegali e condussero alla supremazia di uno solo, al dispotismo, costituendo quindi
una minaccia di rivolta interna contro l’oppressione e di guerre fra Stato e Stato.
L’opera, disapprovata dagli stessi filosofi per la violenza polemica della sua
requisitoria contro le istituzioni politiche e sociali, non fu premiata. I suoi temi
furono ripresi e ulteriormente svolti da Rousseau nel Contratto sociale*.
Discorso sul metodo per ben dirigere la propria ragione e cercare la verità nelle
scienze (Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité
dans les sciences), opera di Cartesio (Leida, 1637). Scritto in francese perché fosse
accessibile a un vasto pubblico, era destinato a esporre i principi e la forma di
pensiero applicati nella Diottrica, nelle Meteore e nella Geometria, cui serviva da
prefazione. Cartesio, respingendo ogni forma di autorità, vi postula il diritto, per
ogni pensiero che sappia condursi in modo conveniente, di costituire la scienza a
partire dai principi che formano « il buon senso », che è nella stessa misura in tutte