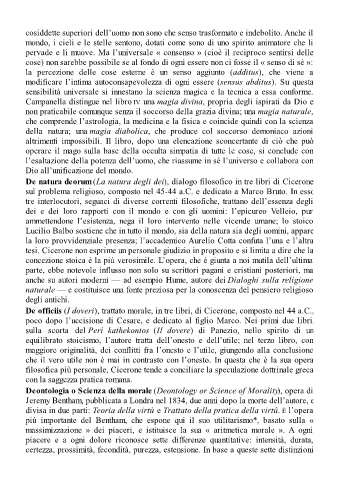Page 905 - Dizionario di Filosofia
P. 905
cosiddette superiori dell’uomo non sono che senso trasformato e indebolito. Anche il
mondo, i cieli e le stelle sentono, dotati come sono di uno spirito animatore che li
pervade e li muove. Ma l’universale « consenso » (cioè il reciproco sentirsi delle
cose) non sarebbe possibile se al fondo di ogni essere non ci fosse il « senso di sé »:
la percezione delle cose esterne è un senso aggiunto (additus), che viene a
modificare l’intima autoconsapevolezza di ogni essere (sensus abditus). Su questa
sensibilità universale si innestano la scienza magica e la tecnica a essa conforme.
Campanella distingue nel libro IV una magia divina, propria degli ispirati da Dio e
non praticabile comunque senza il soccorso della grazia divina; una magia naturale,
che comprende l’astrologia, la medicina e la fisica e coincide quindi con la scienza
della natura; una magia diabolica, che produce col soccorso demoniaco azioni
altrimenti impossibili. Il libro, dopo una elencazione sconcertante di ciò che può
operare il mago sulla base della occulta simpatia di tutte le cose, si conclude con
l’esaltazione della potenza dell’uomo, che riassume in sé l’universo e collabora con
Dio all’unificazione del mondo.
De natura deorum (La natura degli dei), dialogo filosofico in tre libri di Cicerone
sul problema religioso, composto nel 45-44 a.C. e dedicato a Marco Bruto. In esso
tre interlocutori, seguaci di diverse correnti filosofiche, trattano dell’essenza degli
dei e dei loro rapporti con il mondo e con gli uomini: l’epicureo Velleio, pur
ammettendone l’esistenza, nega il loro intervento nelle vicende umane; lo stoico
Lucilio Balbo sostiene che in tutto il mondo, sia della natura sia degli uomini, appare
la loro provvidenziale presenza; l’accademico Aurelio Cotta confuta l’una e l’altra
tesi. Cicerone non esprime un personale giudizio in proposito e si limita a dire che la
concezione stoica è la più verosimile. L’opera, che è giunta a noi mutila dell’ultima
parte, ebbe notevole influsso non solo su scrittori pagani e cristiani posteriori, ma
anche su autori moderni — ad esempio Hume, autore dei Dialoghi sulla religione
naturale — e costituisce una fonte preziosa per la conoscenza del pensiero religioso
degli antichi.
De officiis (I doveri), trattato morale, in tre libri, di Cicerone, composto nel 44 a.C.,
poco dopo l’uccisione di Cesare, e dedicato al figlio Marco. Nei primi due libri,
sulla scorta del Perì kathekontos (Il dovere) di Panezio, nello spirito di un
equilibrato stoicismo, l’autore tratta dell’onesto e dell’utile; nel terzo libro, con
maggiore originalità, dei conflitti fra l’onesto e l’utile, giungendo alla conclusione
che il vero utile non è mai in contrasto con l’onesto. In questa che è la sua opera
filosofica più personale, Cicerone tende a conciliare la speculazione dottrinale greca
con la saggezza pratica romana.
Deontologia o Scienza della morale (Deontology or Science of Morality), opera di
Jeremy Bentham, pubblicata a Londra nel 1834, due anni dopo la morte dell’autore, e
divisa in due parti: Teoria della virtù e Trattato della pratica della virtû. È l’opera
più importante del Bentham, che espone qui il suo utilitarismo*, basato sulla «
massimizzazione » dei piaceri, e istituisce la sua « aritmetica morale ». A ogni
piacere e a ogni dolore riconosce sette differenze quantitative: intensità, durata,
certezza, prossimità, fecondità, purezza, estensione. In base a queste sette distinzioni