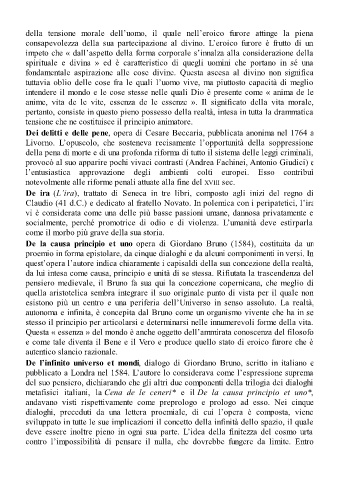Page 902 - Dizionario di Filosofia
P. 902
della tensione morale dell’uomo, il quale nell’eroico furore attinge la piena
consapevolezza della sua partecipazione al divino. L’eroico furore è frutto di un
impeto che « dall’aspetto della forma corporale s’innalza alla considerazione della
spirituale e divina » ed è caratteristico di quegli uomini che portano in sé una
fondamentale aspirazione alle cose divine. Questa ascesa al divino non significa
tuttavia oblio delle cose fra le quali l’uomo vive, ma piuttosto capacità di meglio
intendere il mondo e le cose stesse nelle quali Dio è presente come « anima de le
anime, vita de le vite, essenza de le essenze ». Il significato della vita morale,
pertanto, consiste in questo pieno possesso della realtà, intesa in tutta la drammatica
tensione che ne costituisce il principio animatore.
Dei delitti e delle pene, opera di Cesare Beccaria, pubblicata anonima nel 1764 a
Livorno. L’opuscolo, che sosteneva recisamente l’opportunità della soppressione
della pena di morte e di una profonda riforma di tutto il sistema delle leggi criminali,
provocò al suo apparire pochi vivaci contrasti (Andrea Fachinei, Antonio Giudici) e
l’entusiastica approvazione degli ambienti colti europei. Esso contribuì
notevolmente alle riforme penali attuate alla fine del XVIII sec.
De ira (L’ira), trattato di Seneca in tre libri, composto agli inizi del regno di
Claudio (41 d.C.) e dedicato al fratello Novato. In polemica con i peripatetici, l’ira
vi è considerata come una delle più basse passioni umane, dannosa privatamente e
socialmente, perché promotrice di odio e di violenza. L’umanità deve estirparla
come il morbo più grave della sua storia.
De la causa principio et uno opera di Giordano Bruno (1584), costituita da un
proemio in forma epistolare, da cinque dialoghi e da alcuni componimenti in versi. In
quest’opera l’autore indica chiaramente i capisaldi della sua concezione della realtà,
da lui intesa come causa, principio e unità di se stessa. Rifiutata la trascendenza del
pensiero medievale, il Bruno fa sua qui la concezione copernicana, che meglio di
quella aristotelica sembra integrare il suo originale punto di vista per il quale non
esistono più un centro e una periferia dell’Universo in senso assoluto. La realtà,
autonoma e infinita, è concepita dal Bruno come un organismo vivente che ha in se
stesso il principio per articolarsi e determinarsi nelle innumerevoli forme della vita.
Questa « essenza » del mondo è anche oggetto dell’ammirata conoscenza del filosofo
e come tale diventa il Bene e il Vero e produce quello stato di eroico furore che è
autentico slancio razionale.
De l’infinito universo et mondi, dialogo di Giordano Bruno, scritto in italiano e
pubblicato a Londra nel 1584. L’autore lo considerava come l’espressione suprema
del suo pensiero, dichiarando che gli altri due componenti della trilogia dei dialoghi
metafisici italiani, la Cena de le ceneri* e il De la causa principio et uno*,
andavano visti rispettivamente come preprologo e prologo ad esso. Nei cinque
dialoghi, preceduti da una lettera proemiale, di cui l’opera è composta, viene
sviluppato in tutte le sue implicazioni il concetto della infinità dello spazio, il quale
deve essere inoltre pieno in ogni sua parte. L’idea della finitezza del cosmo urta
contro l’impossibilità di pensare il nulla, che dovrebbe fungere da limite. Entro