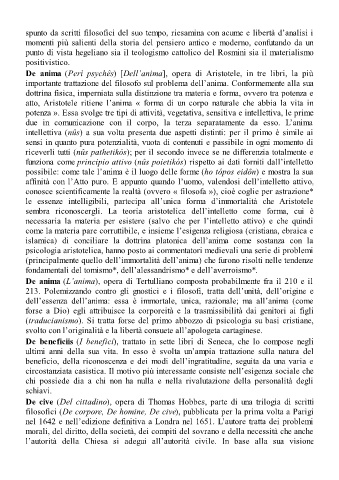Page 898 - Dizionario di Filosofia
P. 898
spunto da scritti filosofici del suo tempo, riesamina con acume e libertà d’analisi i
momenti più salienti della storia del pensiero antico e moderno, confutando da un
punto di vista hegeliano sia il teologismo cattolico del Rosmini sia il materialismo
positivistico.
De anima (Perì psychês) [Dell’anima], opera di Aristotele, in tre libri, la più
importante trattazione del filosofo sul problema dell’anima. Conformemente alla sua
dottrina fisica, imperniata sulla distinzione tra materia e forma, ovvero tra potenza e
atto, Aristotele ritiene l’anima « forma di un corpo naturale che abbia la vita in
potenza ». Essa svolge tre tipi di attività, vegetativa, sensitiva e intellettiva, le prime
due in comunicazione con il corpo, la terza separatamente da esso. L’anima
intellettiva (nûs) a sua volta presenta due aspetti distinti: per il primo è simile ai
sensi in quanto pura potenzialità, vuota di contenuti e passibile in ogni momento di
riceverli tutti (nûs pathetikós); per il secondo invece se ne differenzia totalmente e
funziona come principio attivo (nûs poietikós) rispetto ai dati forniti dall’intelletto
possibile: come tale l’anima è il luogo delle forme (ho tópos eidôn) e mostra la sua
affinità con l’Atto puro. E appunto quando l’uomo, valendosi dell’intelletto attivo,
conosce scientificamente la realtà (ovvero « filosofa »), cioè coglie per astrazione*
le essenze intelligibili, partecipa all’unica forma d’immortalità che Aristotele
sembra riconoscergli. La teoria aristotelica dell’intelletto come forma, cui è
necessaria la materia per esistere (salvo che per l’intelletto attivo) e che quindi
come la materia pare corruttibile, e insieme l’esigenza religiosa (cristiana, ebraica e
islamica) di conciliare la dottrina platonica dell’anima come sostanza con la
psicologia aristotelica, hanno posto ai commentatori medievali una serie di problemi
(principalmente quello dell’immortalità dell’anima) che furono risolti nelle tendenze
fondamentali del tomismo*, dell’alessandrismo* e dell’averroismo*.
De anima (L’anima), opera di Tertulliano composta probabilmente fra il 210 e il
213. Polemizzando contro gli gnostici e i filosofi, tratta dell’unità, dell’origine e
dell’essenza dell’anima: essa è immortale, unica, razionale; ma all’anima (come
forse a Dio) egli attribuisce la corporeità e la trasmissibilità dai genitori ai figli
(traducianismo). Si tratta forse del primo abbozzo di psicologia su basi cristiane,
svolto con l’originalità e la libertà consuete all’apologeta cartaginese.
De beneficiis (I benefici), trattato in sette libri di Seneca, che lo compose negli
ultimi anni della sua vita. In esso è svolta un’ampia trattazione sulla natura del
beneficio, della riconoscenza e dei modi dell’ingratitudine, seguita da una varia e
circostanziata casistica. Il motivo più interessante consiste nell’esigenza sociale che
chi possiede dia a chi non ha nulla e nella rivalutazione della personalità degli
schiavi.
De cive (Del cittadino), opera di Thomas Hobbes, parte di una trilogia di scritti
filosofici (De corpore, De homine, De cive), pubblicata per la prima volta a Parigi
nel 1642 e nell’edizione definitiva a Londra nel 1651. L’autore tratta dei problemi
morali, del diritto, della società, dei compiti del sovrano e della necessità che anche
l’autorità della Chiesa si adegui all’autorità civile. In base alla sua visione