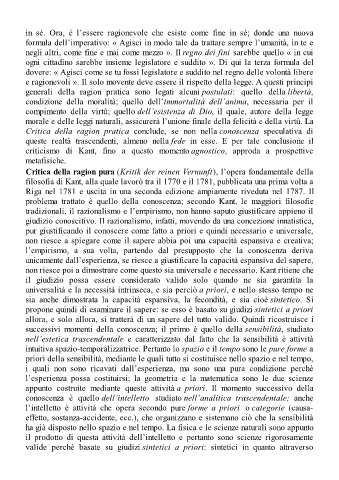Page 896 - Dizionario di Filosofia
P. 896
in sé. Ora, è l’essere ragionevole che esiste come fine in sé; donde una nuova
formula dell’imperativo: « Agisci in modo tale da trattare sempre l’umanità, in te e
negli altri, come fine e mai come mezzo ». Il regno dei fini sarebbe quello « in cui
ogni cittadino sarebbe insieme legislatore e suddito ». Di qui la terza formula del
dovere: « Agisci come se tu fossi legislatore e suddito nel regno delle volontà libere
e ragionevoli ». Il solo movente deve essere il rispetto della legge. A questi principi
generali della ragion pratica sono legati alcuni postulati: quello della libertà,
condizione della moralità; quello dell’immortalità dell’anima, necessaria per il
compimento della virtû; quello dell’esistenza di Dio, il quale, autore della legge
morale e delle leggi naturali, assicurerà l’unione finale della felicità e della virtû. La
Critica della ragion pratica conclude, se non nella conoscenza speculativa di
queste realtà trascendenti, almeno nella fede in esse. E per tale conclusione il
criticismo di Kant, fino a questo momento agnostico, approda a prospettive
metafisiche.
Critica della ragion pura (Kritik der reinen Vernunft), l’opera fondamentale della
filosofia di Kant, alla quale lavorò tra il 1770 e il 1781, pubblicata una prima volta a
Riga nel 1781 e uscita in una seconda edizione ampiamente riveduta nel 1787. Il
problema trattato è quello della conoscenza; secondo Kant, le maggiori filosofìe
tradizionali, il razionalismo e l’empirismo, non hanno saputo giustificare appieno il
giudizio conoscitivo. Il razionalismo, infatti, movendo da una concezione innatistica,
pur giustificando il conoscere come fatto a priori e quindi necessario e universale,
non riesce a spiegare come il sapere abbia poi una capacità espansiva e creativa;
l’empirismo, a sua volta, partendo dal presupposto che la conoscenza deriva
unicamente dall’esperienza, se riesce a giustificare la capacità espansiva del sapere,
non riesce poi a dimostrare come questo sia universale e necessario. Kant ritiene che
il giudizio possa essere considerato valido solo quando ne sia garantita la
universalità e la necessità intrinseca, e sia perciò a priori, e nello stesso tempo ne
sia anche dimostrata la capacità espansiva, la fecondità, e sia cioè sintetico. Si
propone quindi di esaminare il sapere: se esso è basato su giudizi sintetici a priori
allora, e solo allora, si tratterà di un sapere del tutto valido. Quindi ricostruisce i
successivi momenti della conoscenza; il primo è quello della sensibilità, studiato
nell’estetica trascendentale e caratterizzato dal fatto che la sensibilità è attività
intuitiva spazio-temporalizzatrice. Pertanto lo spazio e il tempo sono le pure forme a
priori della sensibilità, mediante le quali tutto si costituisce nello spazio e nel tempo,
i quali non sono ricavati dall’esperienza, ma sono una pura condizione perché
l’esperienza possa costituirsi; la geometria e la matematica sono le due scienze
appunto costruite mediante queste attività a priori. Il momento successivo della
conoscenza è quello dell’intelletto studiato nell’analitica trascendentale; anche
l’intelletto è attività che opera secondo pure forme a priori o categorie (causa-
effetto, sostanza-accidente, ecc.), che organizzano e sistemano ciò che la sensibilità
ha già disposto nello spazio e nel tempo. La fisica e le scienze naturali sono appunto
il prodotto di questa attività dell’intelletto e pertanto sono scienze rigorosamente
valide perché basate su giudizi sintetici a priori: sintetici in quanto attraverso