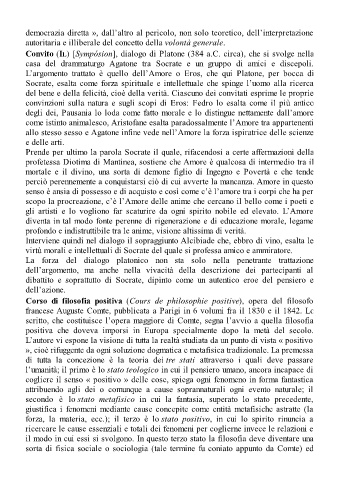Page 892 - Dizionario di Filosofia
P. 892
democrazia diretta », dall’altro al pericolo, non solo teoretico, dell’interpretazione
autoritaria e illiberale del concetto della volontà generale.
Convito (IL) [Sympósion], dialogo di Platone (384 a.C. circa), che si svolge nella
casa del drammaturgo Agatone tra Socrate e un gruppo di amici e discepoli.
L’argomento trattato è quello dell’Amore o Eros, che qui Platone, per bocca di
Socrate, esalta come forza spirituale e intellettuale che spinge l’uomo alla ricerca
del bene e della felicità, cioè della verità. Ciascuno dei convitati esprime le proprie
convinzioni sulla natura e sugli scopi di Eros: Fedro lo esalta come il più antico
degli dei, Pausania lo loda come fatto morale e lo distingue nettamente dall’amore
come istinto animalesco, Aristofane esalta paradossalmente l’Amore tra appartenenti
allo stesso sesso e Agatone infine vede nell’Amore la forza ispiratrice delle scienze
e delle arti.
Prende per ultimo la parola Socrate il quale, rifacendosi a certe affermazioni della
profetessa Diotima di Mantinea, sostiene che Amore è qualcosa di intermedio tra il
mortale e il divino, una sorta di demone figlio di Ingegno e Povertà e che tende
perciò perennemente a conquistarsi ciò di cui avverte la mancanza. Amore in questo
senso è ansia di possesso e di acquisto e così come c’è l’amore tra i corpi che ha per
scopo la procreazione, c’è l’Amore delle anime che cercano il bello come i poeti e
gli artisti e lo vogliono far scaturire da ogni spirito nobile ed elevato. L’Amore
diventa in tal modo fonte perenne di rigenerazione e di educazione morale, legame
profondo e indistruttibile tra le anime, visione altissima di verità.
Interviene quindi nel dialogo il sopraggiunto Alcibiade che, ebbro di vino, esalta le
virtù morali e intellettuali di Socrate del quale si professa amico e ammiratore.
La forza del dialogo platonico non sta solo nella penetrante trattazione
dell’argomento, ma anche nella vivacità della descrizione dei partecipanti al
dibattito e soprattutto di Socrate, dipinto come un autentico eroe del pensiero e
dell’azione.
Corso di filosofia positiva (Cours de philosophie positive), opera del filosofo
francese Auguste Comte, pubblicata a Parigi in 6 volumi fra il 1830 e il 1842. Lo
scritto, che costituisce l’opera maggiore di Comte, segna l’avvio a quella filosofia
positiva che doveva imporsi in Europa specialmente dopo la metà del secolo.
L’autore vi espone la visione di tutta la realtà studiata da un punto di vista « positivo
», cioè rifuggente da ogni soluzione dogmatica e metafisica tradizionale. La premessa
di tutta la concezione è la teoria dei tre stati attraverso i quali deve passare
l’umanità; il primo è lo stato teologico in cui il pensiero umano, ancora incapace di
cogliere il senso « positivo » delle cose, spiega ogni fenomeno in forma fantastica
attribuendo agli dei o comunque a cause soprannaturali ogni evento naturale; il
secondo è lo stato metafisico in cui la fantasia, superato lo stato precedente,
giustifica i fenomeni mediante cause concepite come entità metafisiche astratte (la
forza, la materia, ecc.); il terzo è lo stato positivo, in cui lo spirito rinuncia a
ricercare le cause essenziali e totali dei fenomeni per coglierne invece le relazioni e
il modo in cui essi si svolgono. In questo terzo stato la filosofia deve diventare una
sorta di fisica sociale o sociologia (tale termine fu coniato appunto da Comte) ed