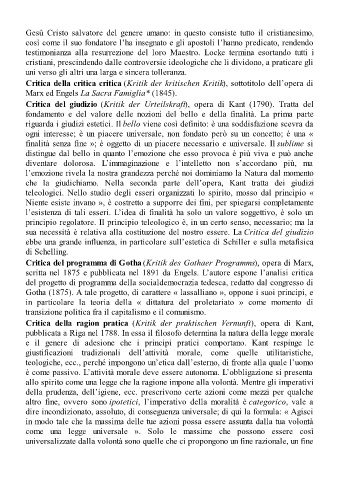Page 895 - Dizionario di Filosofia
P. 895
Gesû Cristo salvatore del genere umano: in questo consiste tutto il cristianesimo,
così come il suo fondatore l’ha insegnato e gli apostoli l’hanno predicato, rendendo
testimonianza alla resurrezione del loro Maestro. Locke termina esortando tutti i
cristiani, prescindendo dalle controversie ideologiche che li dividono, a praticare gli
uni verso gli altri una larga e sincera tolleranza.
Critica della critica critica (Kritik der kritischen Kritik), sottotitolo dell’opera di
Marx ed Engels La Sacra Famiglia* (1845).
Critica del giudizio (Kritik der Urteilskraft), opera di Kant (1790). Tratta del
fondamento e del valore delle nozioni del bello e della finalità. La prima parte
riguarda i giudizi estetici. Il bello viene così definito: è una soddisfazione scevra da
ogni interesse; è un piacere universale, non fondato però su un concetto; è una «
finalità senza fine »; è oggetto di un piacere necessario e universale. Il sublime si
distingue dal bello in quanto l’emozione che esso provoca è più viva e può anche
diventare dolorosa. L’immaginazione e l’intelletto non s’accordano più, ma
l’emozione rivela la nostra grandezza perché noi dominiamo la Natura dal momento
che la giudichiamo. Nella seconda parte dell’opera, Kant tratta dei giudizi
teleologici. Nello studio degli esseri organizzati lo spirito, mosso dal principio «
Niente esiste invano », è costretto a supporre dei fini, per spiegarsi completamente
l’esistenza di tali esseri. L’idea di finalità ha solo un valore soggettivo, è solo un
principio regolatore. Il principio teleologico è, in un certo senso, necessario; ma la
sua necessità è relativa alla costituzione del nostro essere. La Critica del giudizio
ebbe una grande influenza, in particolare sull’estetica di Schiller e sulla metafìsica
di Schelling.
Critica del programma di Gotha (Kritik des Gothaer Programms), opera di Marx,
scritta nel 1875 e pubblicata nel 1891 da Engels. L’autore espone l’analisi critica
del progetto di programma della socialdemocrazia tedesca, redatto dal congresso di
Gotha (1875). A tale progetto, di carattere « lassalliano », oppone i suoi principi, e
in particolare la teoria della « dittatura del proletariato » come momento di
transizione politica fra il capitalismo e il comunismo.
Critica della ragion pratica (Kritik der praktischen Vernunft), opera di Kant,
pubblicata a Riga nel 1788. In essa il filosofo determina la natura della legge morale
e il genere di adesione che i principi pratici comportano. Kant respinge le
giustificazioni tradizionali dell’attività morale, come quelle utilitaristiche,
teologiche, ecc., perché impongono un’etica dall’esterno, di fronte alla quale l’uomo
è come passivo. L’attività morale deve essere autonoma. L’obbligazione si presenta
allo spirito come una legge che la ragione impone alla volontà. Mentre gli imperativi
della prudenza, dell’igiene, ecc. prescrivono certe azioni come mezzi per qualche
altro fine, ovvero sono ipotetici, l’imperativo della moralità è categorico, vale a
dire incondizionato, assoluto, di conseguenza universale; di qui la formula: « Agisci
in modo tale che la massima delle tue azioni possa essere assunta dalla tua volontà
come una legge universale ». Solo le massime che possono essere così
universalizzate dalla volontà sono quelle che ci propongono un fine razionale, un fine