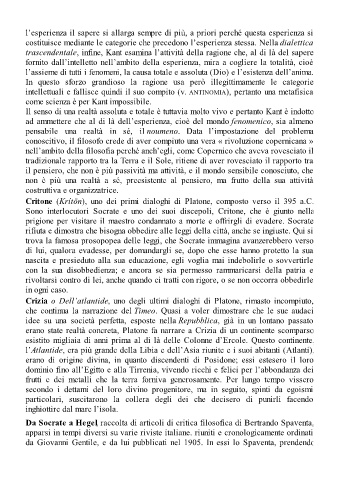Page 897 - Dizionario di Filosofia
P. 897
l’esperienza il sapere si allarga sempre di più, a priori perché questa esperienza si
costituisce mediante le categorie che precedono l’esperienza stessa. Nella dialettica
trascendentale, infine, Kant esamina l’attività della ragione che, al di là del sapere
fornito dall’intelletto nell’ambito della esperienza, mira a cogliere la totalità, cioè
l’assieme di tutti i fenomeni, la causa totale e assoluta (Dio) e l’esistenza dell’anima.
In questo sforzo grandioso la ragione usa però illegittimamente le categorie
intellettuali e fallisce quindi il suo compito (v. ANTINOMIA), pertanto una metafisica
come scienza è per Kant impossibile.
Il senso di una realtà assoluta e totale è tuttavia molto vivo e pertanto Kant è indotto
ad ammettere che al di là dell’esperienza, cioè del mondo fenomenico, sia almeno
pensabile una realtà in sé, il noumeno. Data l’impostazione del problema
conoscitivo, il filosofo crede di aver compiuto una vera « rivoluzione copernicana »
nell’ambito della filosofia perché anch’egli, come Copernico che aveva rovesciato il
tradizionale rapporto tra la Terra e il Sole, ritiene di aver rovesciato il rapporto tra
il pensiero, che non è più passività ma attività, e il mondo sensibile conosciuto, che
non è più una realtà a sé, preesistente al pensiero, ma frutto della sua attività
costruttiva e organizzatrice.
Critone (Krítōn), uno dei primi dialoghi di Platone, composto verso il 395 a.C.
Sono interlocutori Socrate e uno dei suoi discepoli, Critone, che è giunto nella
prigione per visitare il maestro condannato a morte e offrirgli di evadere. Socrate
rifiuta e dimostra che bisogna obbedire alle leggi della città, anche se ingiuste. Qui si
trova la famosa prosopopea delle leggi, che Socrate immagina avanzerebbero verso
di lui, qualora evadesse, per domandargli se, dopo che esse hanno protetto la sua
nascita e presieduto alla sua educazione, egli voglia mai indebolirle o sovvertirle
con la sua disobbedienza; e ancora se sia permesso rammaricarsi della patria e
rivoltarsi contro di lei, anche quando ci tratti con rigore, o se non occorra obbedirle
in ogni caso.
Crizia o Dell’atlantide, uno degli ultimi dialoghi di Platone, rimasto incompiuto,
che continua la narrazione del Timeo. Quasi a voler dimostrare che le sue audaci
idee su una società perfetta, esposte nella Repubblica, già in un lontano passato
erano state realtà concreta, Platone fa narrare a Crizia di un continente scomparso
esistito migliaia di anni prima al di là delle Colonne d’Ercole. Questo continente,
l’Atlantide, era più grande della Libia e dell’Asia riunite e i suoi abitanti (Atlanti),
erano di origine divina, in quanto discendenti di Posidone; essi estesero il loro
dominio fino all’Egitto e alla Tirrenia, vivendo ricchi e felici per l’abbondanza dei
frutti e dei metalli che la terra forniva generosamente. Per lungo tempo vissero
secondo i dettami del loro divino progenitore, ma in seguito, spinti da egoismi
particolari, suscitarono la collera degli dei che decisero di punirli facendo
inghiottire dal mare l’isola.
Da Socrate a Hegel, raccolta di articoli di critica filosofica di Bertrando Spaventa,
apparsi in tempi diversi su varie riviste italiane. riuniti e cronologicamente ordinati
da Giovanni Gentile, e da lui pubblicati nel 1905. In essi lo Spaventa, prendendo