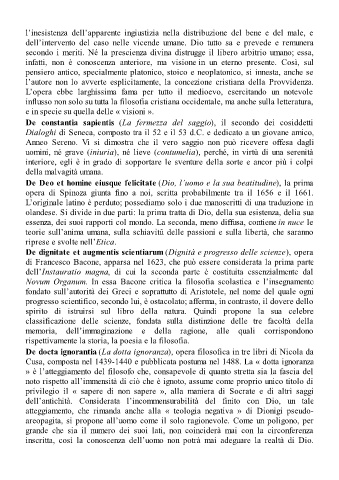Page 900 - Dizionario di Filosofia
P. 900
l’inesistenza dell’apparente ingiustizia nella distribuzione del bene e del male, e
dell’intervento del caso nelle vicende umane. Dio tutto sa e prevede e remunera
secondo i meriti. Né la prescienza divina distrugge il libero arbitrio umano; essa,
infatti, non è conoscenza anteriore, ma visione in un eterno presente. Così, sul
pensiero antico, specialmente platonico, stoico e neoplatonico, si innesta, anche se
l’autore non lo avverte esplicitamente, la concezione cristiana della Provvidenza.
L’opera ebbe larghissima fama per tutto il medioevo, esercitando un notevole
influsso non solo su tutta la filosofia cristiana occidentale, ma anche sulla letteratura,
e in specie su quella delle « visioni ».
De constantia sapientis (La fermezza del saggio), il secondo dei cosiddetti
Dialoghi di Seneca, composto tra il 52 e il 53 d.C. e dedicato a un giovane amico,
Anneo Sereno. Vi si dimostra che il vero saggio non può ricevere offesa dagli
uomini, né grave (iniuria), né lieve (contumelia), perché, in virtù di una serenità
interiore, egli è in grado di sopportare le sventure della sorte e ancor più i colpi
della malvagità umana.
De Deo et homine eiusque felicitate (Dio, l’uomo e la sua beatitudine), la prima
opera di Spinoza giunta fino a noi, scritta probabilmente tra il 1656 e il 1661.
L’originale latino è perduto; possediamo solo i due manoscritti di una traduzione in
olandese. Si divide in due parti: la prima tratta di Dio, della sua esistenza, delia sua
essenza, dei suoi rapporti col mondo. La seconda, meno diffusa, contiene in nuce le
teorie sull’anima umana, sulla schiavitû delle passioni e sulla libertà, che saranno
riprese e svolte nell’Etica.
De dignitate et augmentis scientiarum (Dignità e progresso delle scienze), opera
di Francesco Bacone, apparsa nel 1623, che può essere considerata la prima parte
dell’Instauratio magna, di cui la seconda parte è costituita essenzialmente dal
Novum Organum. In essa Bacone critica la filosofia scolastica e l’insegnamento
fondato sull’autorità dei Greci e soprattutto di Aristotele, nel nome del quale ogni
progresso scientifico, secondo lui, è ostacolato; afferma, in contrasto, il dovere dello
spirito di istruirsi sul libro della natura. Quindi propone la sua celebre
classificazione delle scienze, fondata sulla distinzione delle tre facoltà della
memoria, dell’immaginazione e della ragione, alle quali corrispondono
rispettivamente la storia, la poesia e la filosofia.
De docta ignorantia (La dotta ignoranza), opera filosofica in tre libri di Nicola da
Cusa, composta nel 1439-1440 e pubblicata postuma nel 1488. La « dotta ignoranza
» è l’atteggiamento del filosofo che, consapevole di quanto stretta sia la fascia del
noto rispetto all’immensità di ciò che è ignoto, assume come proprio unico titolo di
privilegio il « sapere di non sapere », alla maniera di Socrate e di altri saggi
dell’antichità. Considerata l’incommensurabilità del finito con Dio, un tale
atteggiamento, che rimanda anche alla « teologia negativa » di Dionigi pseudo-
areopagita, si propone all’uomo come il solo ragionevole. Come un poligono, per
grande che sia il numero dei suoi lati, non coinciderà mai con la circonferenza
inscritta, così la conoscenza dell’uomo non potrà mai adeguare la realtà di Dio.