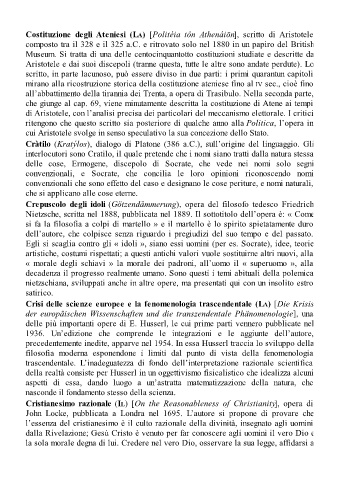Page 894 - Dizionario di Filosofia
P. 894
Costituzione degli Ateniesi (LA) [Politéia tôn Athenáiōn], scritto di Aristotele
composto tra il 328 e il 325 a.C. e ritrovato solo nel 1880 in un papiro del British
Museum. Si tratta di una delle centocinquantotto costituzioni studiate e descritte da
Aristotele e dai suoi discepoli (tranne questa, tutte le altre sono andate perdute). Lo
scritto, in parte lacunoso, può essere diviso in due parti: i primi quarantun capitoli
mirano alla ricostruzione storica della costituzione ateniese fino al IV sec., cioè fino
all’abbattimento della tirannia dei Trenta, a opera di Trasibulo. Nella seconda parte,
che giunge al cap. 69, viene minutamente descritta la costituzione di Atene ai tempi
di Aristotele, con l’analisi precisa dei particolari del meccanismo elettorale. I critici
ritengono che questo scritto sia posteriore di qualche anno alla Politica, l’opera in
cui Aristotele svolge in senso speculativo la sua concezione dello Stato.
Cràtilo (Kratýlos), dialogo di Platone (386 a.C.), sull’origine del linguaggio. Gli
interlocutori sono Cratilo, il quale pretende che i nomi siano tratti dalla natura stessa
delle cose, Ermogene, discepolo di Socrate, che vede nei nomi solo segni
convenzionali, e Socrate, che concilia le loro opinioni riconoscendo nomi
convenzionali che sono effetto del caso e designano le cose periture, e nomi naturali,
che si applicano alle cose eterne.
Crepuscolo degli idoli (Götzendämmerung), opera del filosofo tedesco Friedrich
Nietzsche, scritta nel 1888, pubblicata nel 1889. Il sottotitolo dell’opera è: « Come
si fa la filosofia a colpi di martello » e il martello è lo spirito spietatamente duro
dell’autore, che colpisce senza riguardo i pregiudizi del suo tempo e del passato.
Egli si scaglia contro gli « idoli », siano essi uomini (per es. Socrate), idee, teorie
artistiche, costumi rispettati; a questi antichi valori vuole sostituirne altri nuovi, alla
« morale degli schiavi » la morale dei padroni, all’uomo il « superuomo », alla
decadenza il progresso realmente umano. Sono questi i temi abituali della polemica
nietzschiana, sviluppati anche in altre opere, ma presentati qui con un insolito estro
satirico.
Crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (LA) [Die Krisis
der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie], una
delle più importanti opere di E. Husserl, le cui prime parti vennero pubblicate nel
1936. Un’edizione che comprende le integrazioni e le aggiunte dell’autore,
precedentemente inedite, apparve nel 1954. In essa Husserl traccia lo sviluppo della
filosofia moderna esponendone i limiti dal punto di vista della fenomenologia
trascendentale. L’inadeguatezza di fondo dell’interpretazione razionale scientifica
della realtà consiste per Husserl in un oggettivismo fisicalistico che idealizza alcuni
aspetti di essa, dando luogo a un’astratta matematizzazione della natura, che
nasconde il fondamento stesso della scienza.
Cristianesimo razionale (IL) [On the Reasonableness of Christianity], opera di
John Locke, pubblicata a Londra nel 1695. L’autore si propone di provare che
l’essenza del cristianesimo è il culto razionale della divinità, insegnato agli uomini
dalla Rivelazione; Gesù Cristo è venuto per far conoscere agli uomini il vero Dio e
la sola morale degna di lui. Credere nel vero Dio, osservare la sua legge, affidarsi a