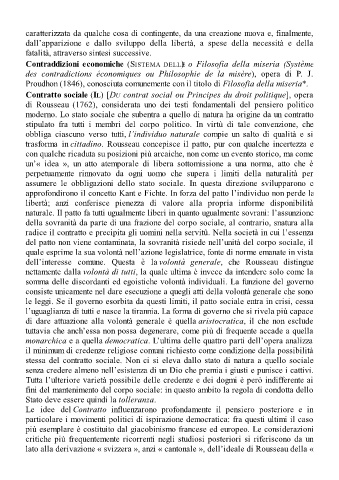Page 891 - Dizionario di Filosofia
P. 891
caratterizzata da qualche cosa di contingente, da una creazione nuova e, finalmente,
dall’apparizione e dallo sviluppo della libertà, a spese della necessità e della
fatalità, attraverso sintesi successive.
Contraddizioni economiche (SISTEMA DELLE) o Filosofia della miseria (Système
des contradictions économiques ou Philosophie de la misère), opera di P. J.
Proudhon (1846), conosciuta comunemente con il titolo di Filosofia della miseria*.
Contratto sociale (IL) [DU contrat social ou Principes du droit politique], opera
di Rousseau (1762), considerata uno dei testi fondamentali del pensiero politico
moderno. Lo stato sociale che subentra a quello di natura ha origine da un contratto
stipulato fra tutti i membri del corpo politico. In virtù di tale convenzione, che
obbliga ciascuno verso tutti, l’individuo naturale compie un salto di qualità e si
trasforma in cittadino. Rousseau concepisce il patto, pur con qualche incertezza e
con qualche ricaduta su posizioni più arcaiche, non come un evento storico, ma come
un’« idea », un atto atemporale di libera sottomissione a una norma, atto che è
perpetuamente rinnovato da ogni uomo che supera i limiti della naturalità per
assumere le obbligazioni dello stato sociale. In questa direzione svilupparono e
approfondirono il concetto Kant e Fichte. In forza del patto l’individuo non perde la
libertà; anzi conferisce pienezza di valore alla propria informe disponibilità
naturale. Il patto fa tutti ugualmente liberi in quanto ugualmente sovrani: l’assunzione
della sovranità da parte di una frazione del corpo sociale, al contrario, snatura alla
radice il contratto e precipita gli uomini nella servitû. Nella società in cui l’essenza
del patto non viene contaminata, la sovranità risiede nell’unità del corpo sociale, il
quale esprime la sua volontà nell’azione legislatrice, fonte di norme emanate in vista
dell’interesse comune. Questa è la volontà generale, che Rousseau distingue
nettamente dalla volontà di tutti, la quale ultima è invece da intendere solo come la
somma delle discordanti ed egoistiche volontà individuali. La funzione del governo
consiste unicamente nel dare esecuzione a quegli atti della volontà generale che sono
le leggi. Se il governo esorbita da questi limiti, il patto sociale entra in crisi, cessa
l’uguaglianza di tutti e nasce la tirannia. La forma di governo che si rivela più capace
di dare attuazione alla volontà generale è quella aristocratica, il che non esclude
tuttavia che anch’essa non possa degenerare, come più di frequente accade a quella
monarchica e a quella democratica. L’ultima delle quattro parti dell’opera analizza
il minimum di credenze religiose comuni richiesto come condizione della possibilità
stessa del contratto sociale. Non ci si eleva dallo stato di natura a quello sociale
senza credere almeno nell’esistenza di un Dio che premia i giusti e punisce i cattivi.
Tutta l’ulteriore varietà possibile delle credenze e dei dogmi è però indifferente ai
fini del mantenimento del corpo sociale: in questo ambito la regola di condotta dello
Stato deve essere quindi la tolleranza.
Le idee del Contratto influenzarono profondamente il pensiero posteriore e in
particolare i movimenti politici di ispirazione democratica: fra questi ultimi il caso
più esemplare è costituito dal giacobinismo francese ed europeo. Le considerazioni
critiche più frequentemente ricorrenti negli studiosi posteriori si riferiscono da un
lato alla derivazione « svizzera », anzi « cantonale », dell’ideale di Rousseau della «