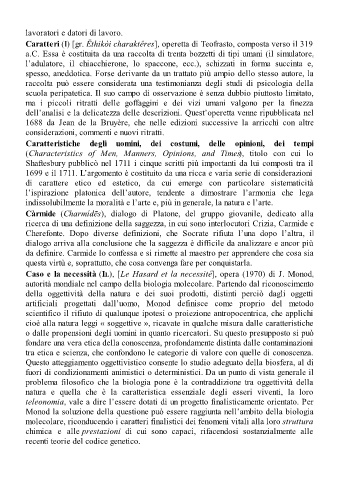Page 887 - Dizionario di Filosofia
P. 887
lavoratori e datori di lavoro.
Caratteri (I) [gr. Ēthikòi charaktêres], operetta di Teofrasto, composta verso il 319
a.C. Essa è costituita da una raccolta di trenta bozzetti di tipi umani (il simulatore,
l’adulatore, il chiacchierone, lo spaccone, ecc.), schizzati in forma succinta e,
spesso, aneddotica. Forse derivante da un trattato più ampio dello stesso autore, la
raccolta può essere considerata una testimonianza degli studi di psicologia della
scuola peripatetica. Il suo campo di osservazione è senza dubbio piuttosto limitato,
ma i piccoli ritratti delle goffaggini e dei vizi umani valgono per la finezza
dell’analisi e la delicatezza delle descrizioni. Quest’operetta venne ripubblicata nel
1688 da Jean de la Bruyère, che nelle edizioni successive la arricchì con altre
considerazioni, commenti e nuovi ritratti.
Caratteristiche degli uomini, dei costumi, delle opinioni, dei tempi
(Characteristics of Men, Manners, Opinions, and Times), titolo con cui lo
Shaftesbury pubblicò nel 1711 i cinque scritti più importanti da lui composti tra il
1699 e il 1711. L’argomento è costituito da una ricca e varia serie di considerazioni
di carattere etico ed estetico, da cui emerge con particolare sistematicità
l’ispirazione platonica dell’autore, tendente a dimostrare l’armonia che lega
indissolubilmente la moralità e l’arte e, più in generale, la natura e l’arte.
Càrmide (Charmídēs), dialogo di Platone, del gruppo giovanile, dedicato alla
ricerca di una definizione della saggezza, in cui sono interlocutori Crizia, Carmide e
Cherefonte. Dopo diverse definizioni, che Socrate rifiuta l’una dopo l’altra, il
dialogo arriva alla conclusione che la saggezza è difficile da analizzare e ancor più
da definire. Carmide lo confessa e si rimette al maestro per apprendere che cosa sia
questa virtù e, soprattutto, che cosa convenga fare per conquistarla.
Caso e la necessità (IL), [Le Hasard et la necessité], opera (1970) di J. Monod,
autorità mondiale nel campo della biologia molecolare. Partendo dal riconoscimento
della oggettività della natura e dei suoi prodotti, distinti perciò dagli oggetti
artificiali progettati dall’uomo, Monod definisce come proprio del metodo
scientifico il rifiuto di qualunque ipotesi o proiezione antropocentrica, che applichi
cioè alla natura leggi « soggettive », ricavate in qualche misura dalle caratteristiche
o dalle propensioni degli uomini in quanto ricercatori. Su questo presupposto si può
fondare una vera etica della conoscenza, profondamente distinta dalle contaminazioni
tra etica e scienza, che confondono le categorie di valore con quelle di conoscenza.
Questo atteggiamento oggettivistico consente lo studio adeguato della biosfera, al di
fuori di condizionamenti animistici o deterministici. Da un punto di vista generale il
problema filosofico che la biologia pone è la contraddizione tra oggettività della
natura e quella che è la caratteristica essenziale degli esseri viventi, la loro
teleonomia, vale a dire l’essere dotati di un progetto finalisticamente orientato. Per
Monod la soluzione della questione può essere raggiunta nell’ambito della biologia
molecolare, riconducendo i caratteri finalistici dei fenomeni vitali alla loro struttura
chimica e alle prestazioni di cui sono capaci, rifacendosi sostanzialmente alle
recenti teorie del codice genetico.