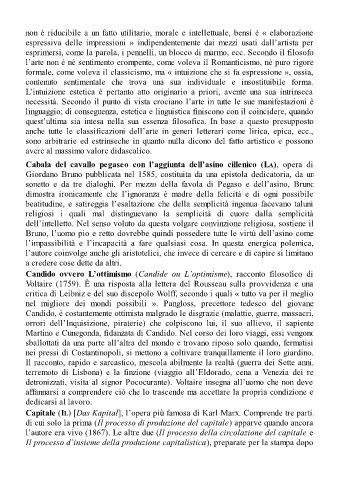Page 885 - Dizionario di Filosofia
P. 885
non è riducibile a un fatto utilitario, morale e intellettuale, bensì è « elaborazione
espressiva delle impressioni » indipendentemente dai mezzi usati dall’artista per
esprimersi, come la parola, i pennelli, un blocco di marmo, ecc. Secondo il filosofo
l’arte non è né sentimento erompente, come voleva il Romanticismo, né puro rigore
formale, come voleva il classicismo, ma « intuizione che si fa espressione », ossia,
contenuto sentimentale che trova una sua individuale e insostituibile forma.
L’intuizione estetica è pertanto atto originario a priori, avente una sua intrinseca
necessità. Secondo il punto di vista crociano l’arte in tutte le sue manifestazioni è
linguaggio; di conseguenza, estetica e linguistica finiscono con il coincidere, quando
quest’ultima sia intesa nella sua essenza filosofica. In base a questo presupposto
anche tutte le classificazioni dell’arte in generi letterari come lirica, epica, ecc.,
sono arbitrarie ed estrinseche in quanto nulla dicono del fatto artistico e possono
avere al massimo valore didascalico.
Cabala del cavallo pegaseo con l’aggiunta dell’asino cillenico (LA), opera di
Giordano Bruno pubblicata nel 1585, costituita da una epistola dedicatoria, da un
sonetto e da tre dialoghi. Per mezzo della favola di Pegaso e dell’asino, Bruno
dimostra ironicamente che l’ignoranza è madre della felicità e di ogni possibile
beatitudine, e satireggia l’esaltazione che della semplicità ingenua facevano taluni
religiosi i quali mal distinguevano la semplicità di cuore dalla semplicità
dell’intelletto. Nel senso voluto da questa volgare convinzione religiosa, sostiene il
Bruno, l’uomo pio e retto dovrebbe quindi possedere tutte le virtù dell’asino come
l’impassibilità e l’incapacità a fare qualsiasi cosa. In questa energica polemica,
l’autore coinvolge anche gli aristotelici, che invece di cercare e di capire si limitano
a credere cose dette da altri.
Candido ovvero L’ottimismo (Candide ou L’optimisme), racconto filosofico di
Voltaire (1759). È una risposta alla lettera del Rousseau sulla provvidenza e una
critica di Leibniz e del suo discepolo Wolff, secondo i quali « tutto va per il meglio
nel migliore dei mondi possibili ». Pangloss, precettore tedesco del giovane
Candido, è costantemente ottimista malgrado le disgrazie (malattie, guerre, massacri,
orrori dell’Inquisizione, piraterie) che colpiscono lui, il suo allievo, il sapiente
Martino e Cunegonda, fidanzata di Candido. Nel corso dei loro viaggi, essi vengono
sballottati da una parte all’altra del mondo e trovano riposo solo quando, fermatisi
nei pressi di Costantinopoli, si mettono a coltivare tranquillamente il loro giardino.
Il racconto, rapido e sarcastico, mescola abilmente la realtà (guerra dei Sette anni,
terremoto di Lisbona) e la finzione (viaggio all’Eldorado, cena a Venezia dei re
detronizzati, visita al signor Pococurante). Voltaire insegna all’uomo che non deve
affannarsi a comprendere ciò che lo trascende ma accettare la propria condizione e
dedicarsi al lavoro.
Capitale (IL) [Das Kapital], l’opera più famosa di Karl Marx. Comprende tre parti,
di cui solo la prima (Il processo di produzione del capitale) apparve quando ancora
l’autore era vivo (1867). Le altre due (Il processo della circolazione del capitale e
Il processo d’insieme della produzione capitalistica), preparate per la stampa dopo