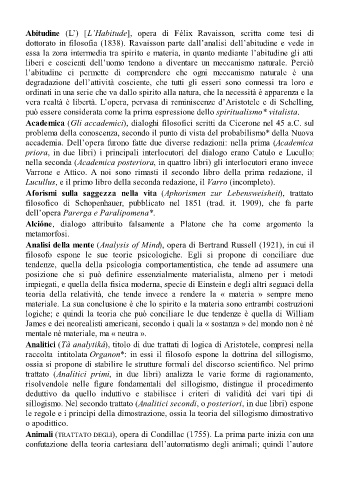Page 881 - Dizionario di Filosofia
P. 881
Abitudine (L’) [L’Habitude], opera di Félix Ravaisson, scritta come tesi di
dottorato in filosofia (1838). Ravaisson parte dall’analisi dell’abitudine e vede in
essa la zona intermedia tra spirito e materia, in quanto mediante l’abitudine gli atti
liberi e coscienti dell’uomo tendono a diventare un meccanismo naturale. Perciò
l’abitudine ci permette di comprendere che ogni meccanismo naturale è una
degradazione dell’attività cosciente, che tutti gli esseri sono connessi tra loro e
ordinati in una serie che va dallo spirito alla natura, che la necessità è apparenza e la
vera realtà è libertà. L’opera, pervasa di reminiscenze d’Aristotele e di Schelling,
può essere considerata come la prima espressione dello spiritualismo* vitalista.
Academica (Gli accademici), dialoghi filosofici scritti da Cicerone nel 45 a.C. sul
problema della conoscenza, secondo il punto di vista del probabilismo* della Nuova
accademia. Dell’opera furono fatte due diverse redazioni: nella prima (Academica
priora, in due libri) i principali interlocutori del dialogo erano Catulo e Lucullo;
nella seconda (Academica posteriora, in quattro libri) gli interlocutori erano invece
Varrone e Attico. A noi sono rimasti il secondo libro della prima redazione, il
Lucullus, e il primo libro della seconda redazione, il Varro (incompleto).
Aforismi sulla saggezza nella vita (Aphorismen zur Lebensweisheit), trattato
filosofico di Schopenhauer, pubblicato nel 1851 (trad. it. 1909), che fa parte
dell’opera Parerga e Paralipomena*.
Alcióne, dialogo attribuito falsamente a Platone che ha come argomento la
metamorfosi.
Analisi della mente (Analysis of Mind), opera di Bertrand Russell (1921), in cui il
filosofo espone le sue teorie psicologiche. Egli si propone di conciliare due
tendenze, quella della psicologia comportamentistica, che tende ad assumere una
posizione che si può definire essenzialmente materialista, almeno per i metodi
impiegati, e quella della fisica moderna, specie di Einstein e degli altri seguaci della
teoria della relatività, che tende invece a rendere la « materia » sempre meno
materiale. La sua conclusione è che lo spirito e la materia sono entrambi costruzioni
logiche; e quindi la teoria che può conciliare le due tendenze è quella di William
James e dei neorealisti americani, secondo i quali la « sostanza » del mondo non è né
mentale né materiale, ma « neutra ».
Analitici (Tà analytiká), titolo di due trattati di logica di Aristotele, compresi nella
raccolta intitolata Organon*: in essi il filosofo espone la dottrina del sillogismo,
ossia si propone di stabilire le strutture formali del discorso scientifico. Nel primo
trattato (Analitici primi, in due libri) analizza le varie forme di ragionamento,
risolvendole nelle figure fondamentali del sillogismo, distingue il procedimento
deduttivo da quello induttivo e stabilisce i criteri di validità dei vari tipi di
sillogismo. Nel secondo trattato (Analitici secondi, o posteriori, in due libri) espone
le regole e i princìpi della dimostrazione, ossia la teoria del sillogismo dimostrativo
o apodittico.
Animali (TRATTATO DEGLI), opera di Condillac (1755). La prima parte inizia con una
confutazione della teoria cartesiana dell’automatismo degli animali; quindi l’autore