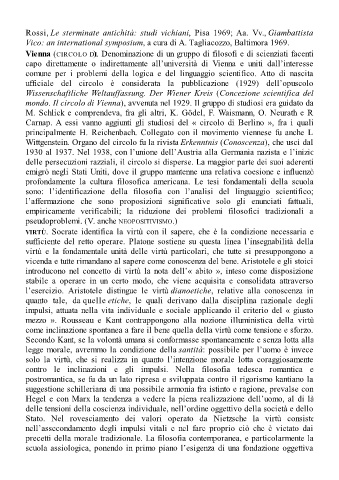Page 863 - Dizionario di Filosofia
P. 863
Rossi, Le sterminate antichità: studi vichiani, Pisa 1969; Aa. Vv., Giambattista
Vico: an international symposium, a cura di A. Tagliacozzo, Baltimora 1969.
Vienna (CIRCOLO DI). Denominazione di un gruppo di filosofi e di scienziati facenti
capo direttamente o indirettamente all’università di Vienna e uniti dall’interesse
comune per i problemi della logica e del linguaggio scientifico. Atto di nascita
ufficiale del circolo è considerata la pubblicazione (1929) dell’opuscolo
Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (Concezione scientifica del
mondo. Il circolo di Vienna), avvenuta nel 1929. Il gruppo di studiosi era guidato da
M. Schlick e comprendeva, fra gli altri, K. Gödel, F. Waismann, O. Neurath e R.
Carnap. A essi vanno aggiunti gli studiosi del « circolo di Berlino », fra i quali
principalmente H. Reichenbach. Collegato con il movimento viennese fu anche L.
Wittgenstein. Organo del circolo fu la rivista Erkenntnis (Conoscenza), che uscì dal
1930 al 1937. Nel 1938, con l’unione dell’Austria alla Germania nazista e l’inizio
delle persecuzioni razziali, il circolo si disperse. La maggior parte dei suoi aderenti
emigrò negli Stati Uniti, dove il gruppo mantenne una relativa coesione e influenzò
profondamente la cultura filosofica americana. Le tesi fondamentali della scuola
sono: l’identificazione della filosofia con l’analisi del linguaggio scientifico;
l’affermazione che sono proposizioni significative solo gli enunciati fattuali,
empiricamente verificabili; la riduzione dei problemi filosofici tradizionali a
pseudoproblemi. (V. anche NEOPOSITIVISMO.)
VIRTÙ. Socrate identifica la virtù con il sapere, che è la condizione necessaria e
sufficiente del retto operare. Platone sostiene su questa linea l’insegnabilità della
virtù e la fondamentale unità delle virtù particolari, che tutte si presuppongono a
vicenda e tutte rimandano al sapere come conoscenza del bene. Aristotele e gli stoici
introducono nel concetto di virtù la nota dell’« abito », inteso come disposizione
stabile a operare in un certo modo, che viene acquisita e consolidata attraverso
l’esercizio. Aristotele distingue le virtù dianoetiche, relative alla conoscenza in
quanto tale, da quelle etiche, le quali derivano dalla disciplina razionale degli
impulsi, attuata nella vita individuale e sociale applicando il criterio del « giusto
mezzo ». Rousseau e Kant contrappongono alla nozione illuministica della virtù
come inclinazione spontanea a fare il bene quella della virtù come tensione e sforzo.
Secondo Kant, se la volontà umana si conformasse spontaneamente e senza lotta alla
legge morale, avremmo la condizione della santità: possibile per l’uomo è invece
solo la virtù, che si realizza in quanto l’intenzione morale lotta coraggiosamente
contro le inclinazioni e gli impulsi. Nella filosofia tedesca romantica e
postromantica, se fu da un lato ripresa e sviluppata contro il rigorismo kantiano la
suggestione schilleriana di una possibile armonia fra istinto e ragione, prevalse con
Hegel e con Marx la tendenza a vedere la piena realizzazione dell’uomo, al di là
delle tensioni della coscienza individuale, nell’ordine oggettivo della società e dello
Stato. Nel rovesciamento dei valori operato da Nietzsche la virtù consiste
nell’assecondamento degli impulsi vitali e nel fare proprio ciò che è vietato dai
precetti della morale tradizionale. La filosofia contemporanea, e particolarmente la
scuola assiologica, ponendo in primo piano l’esigenza di una fondazione oggettiva