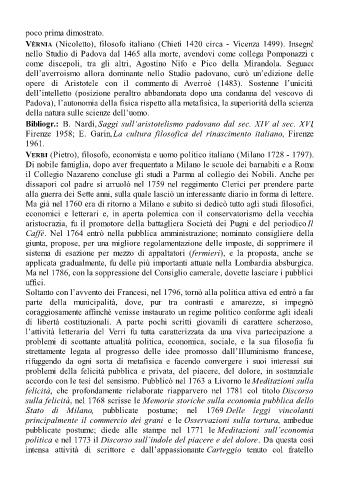Page 860 - Dizionario di Filosofia
P. 860
poco prima dimostrato.
VÈRNIA (Nicoletto), filosofo italiano (Chieti 1420 circa - Vicenza 1499). Insegnò
nello Studio di Padova dal 1465 alla morte, avendovi come collega Pomponazzi e
come discepoli, tra gli altri, Agostino Nifo e Pico della Mirandola. Seguace
dell’averroismo allora dominante nello Studio padovano, curò un’edizione delle
opere di Aristotele con il commento di Averroè (1483). Sostenne l’unicità
dell’intelletto (posizione peraltro abbandonata dopo una condanna del vescovo di
Padova), l’autonomia della fisica rispetto alla metafisica, la superiorità della scienza
della natura sulle scienze dell’uomo.
Bibliogr.: B. Nardi, Saggi sull‘aristotelismo padovano dal sec. XIV al sec. XVI,
Firenze 1958; E. Garin, La cultura filosofica del rinascimento italiano, Firenze
1961.
VERBI (Pietro), filosofo, economista e uomo politico italiano (Milano 1728 - 1797).
Di nobile famiglia, dopo aver frequentato a Milano le scuole dei barnabiti e a Roma
il Collegio Nazareno concluse gli studi a Parma al collegio dei Nobili. Anche per
dissapori col padre si arruolò nel 1759 nel reggimento Clerici per prendere parte
alla guerra dei Sette anni, sulla quale lasciò un interessante diario in forma di lettere.
Ma già nel 1760 era di ritorno a Milano e subito si dedicò tutto agli studi filosofici,
economici e letterari e, in aperta polemica con il conservatorismo della vecchia
aristocrazia, fu il promotore della battagliera Società dei Pugni e del periodico Il
Caffè. Nel 1764 entrò nella pubblica amministrazione; nominato consigliere della
giunta, propose, per una migliore regolamentazione delle imposte, di sopprimere il
sistema di esazione per mezzo di appaltatori (fermieri), e la proposta, anche se
applicata gradualmente, fu delle più importanti attuate nella Lombardia absburgica.
Ma nel 1786, con la soppressione del Consiglio camerale, dovette lasciare i pubblici
uffici.
Soltanto con l’avvento dei Francesi, nel 1796, tornò alla politica attiva ed entrò a far
parte della municipalità, dove, pur tra contrasti e amarezze, si impegnò
coraggiosamente affinché venisse instaurato un regime politico conforme agli ideali
di libertà costituzionali. A parte pochi scritti giovanili di carattere scherzoso,
l’attività letteraria del Verri fu tutta caratterizzata da una viva partecipazione a
problemi di scottante attualità politica, economica, sociale, e la sua filosofia fu
strettamente legata al progresso delle idee promosso dall’Illuminismo francese,
rifuggendo da ogni sorta di metafisica e facendo convergere i suoi interessi sui
problemi della felicità pubblica e privata, del piacere, del dolore, in sostanziale
accordo con le tesi del sensismo. Pubblicò nel 1763 a Livorno le Meditazioni sulla
felicità, che profondamente rielaborate riapparvero nel 1781 col titolo Discorso
sulla felicità, nel 1768 scrisse le Memorie storiche sulla economia pubblica dello
Stato di Milano, pubblicate postume; nel 1769 Delle leggi vincolanti
principalmente il commercio dei grani e le Osservazioni sulla tortura, ambedue
pubblicate postume; diede alle stampe nel 1771 le Meditazioni sull’economia
politica e nel 1773 il Discorso sull’indole del piacere e del dolore. Da questa così
intensa attività di scrittore e dall’appassionante Carteggio tenuto col fratello