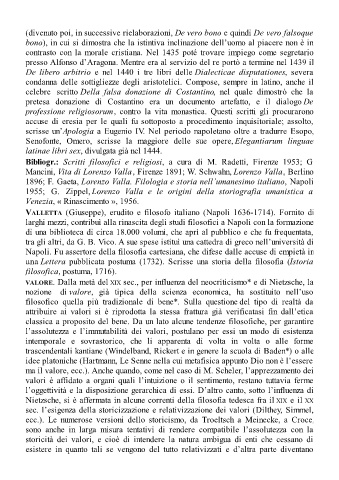Page 856 - Dizionario di Filosofia
P. 856
(divenuto poi, in successive rielaborazioni, De vero bono e quindi De vero falsoque
bono), in cui si dimostra che la istintiva inclinazione dell’uomo al piacere non è in
contrasto con la morale cristiana. Nel 1435 poté trovare impiego come segretario
presso Alfonso d’Aragona. Mentre era al servizio del re portò a termine nel 1439 il
De libero arbitrio e nel 1440 i tre libri delle Dialecticae disputationes, severa
condanna delle sottigliezze degli aristotelici. Compose, sempre in latino, anche il
celebre scritto Della falsa donazione di Costantino, nel quale dimostrò che la
pretesa donazione di Costantino era un documento artefatto, e il dialogo De
professione religiosorum, contro la vita monastica. Questi scritti gli procurarono
accuse di eresia per le quali fu sottoposto a procedimento inquisitoriale; assolto,
scrisse un’Apologia a Eugenio IV. Nel periodo napoletano oltre a tradurre Esopo,
Senofonte, Omero, scrisse la maggiore delle sue opere, Elegantiarum linguae
latinae libri sex, divulgata già nel 1444.
Bibliogr.: Scritti filosofici e religiosi, a cura di M. Radetti, Firenze 1953; G.
Mancini, Vita di Lorenzo Valla, Firenze 1891; W. Schwahn, Lorenzo Valla, Berlino
1896; F. Gaeta, Lorenzo Valla. Filologia e storia nell’umanesimo italiano, Napoli
1955; G. Zippel, Lorenzo Valla e le origini della storiografia umanistica a
Venezia, « Rinascimento », 1956.
VALLETTA (Giuseppe), erudito e filosofo italiano (Napoli 1636-1714). Fornito di
larghi mezzi, contribuì alla rinascita degli studi filosofici a Napoli con la formazione
di una biblioteca di circa 18.000 volumi, che aprì al pubblico e che fu frequentata,
tra gli altri, da G. B. Vico. A sue spese istituì una cattedra di greco nell’università di
Napoli. Fu assertore della filosofia cartesiana, che difese dalle accuse di empietà in
una Lettera pubblicata postuma (1732). Scrisse una storia della filosofia (Istoria
filosofica, postuma, 1716).
VALORE. Dalla metà del XIX sec., per influenza del neocriticismo* e di Nietzsche, la
nozione di valore, già tipica della scienza economica, ha sostituito nell’uso
filosofico quella più tradizionale di bene*. Sulla questione del tipo di realtà da
attribuire ai valori si è riprodotta la stessa frattura già verificatasi fin dall’etica
classica a proposito del bene. Da un lato alcune tendenze filosofiche, per garantire
l’assolutezza e l’immutabilità dei valori, postulano per essi un modo di esistenza
intemporale e sovrastorico, che li apparenta di volta in volta o alle forme
trascendentali kantiane (Windelband, Rickert e in genere la scuola di Baden*) o alle
idee platoniche (Hartmann, Le Senne nella cui metafisica appunto Dio non è l’essere,
ma il valore, ecc.). Anche quando, come nel caso di M. Scheler, l’apprezzamento dei
valori è affidato a organi quali l’intuizione o il sentimento, restano tuttavia ferme
l’oggettività e la disposizione gerarchica di essi. D’altro canto, sotto l’influenza di
Nietzsche, si è affermata in alcune correnti della filosofia tedesca fra il XIX e il XX
sec. l’esigenza della storicizzazione e relativizzazione dei valori (Dilthey, Simmel,
ecc.). Le numerose versioni dello storicismo, da Troeltsch a Meinecke, a Croce,
sono anche in larga misura tentativi di rendere compatibile l’assolutezza con la
storicità dei valori, e cioè di intendere la natura ambigua di enti che cessano di
esistere in quanto tali se vengono del tutto relativizzati e d’altra parte diventano