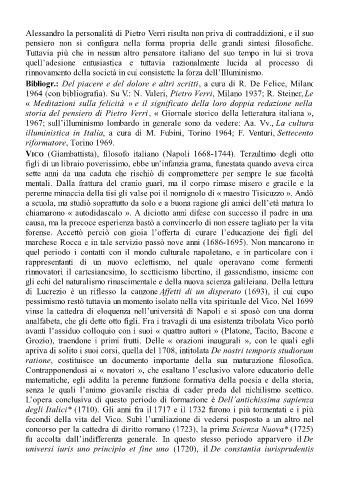Page 861 - Dizionario di Filosofia
P. 861
Alessandro la personalità di Pietro Verri risulta non priva di contraddizioni, e il suo
pensiero non si configura nella forma propria delle grandi sintesi filosofiche.
Tuttavia più che in nessun altro pensatore italiano del suo tempo in lui si trova
quell’adesione entusiastica e tuttavia razionalmente lucida al processo di
rinnovamento della società in cui consistette la forza dell’Illuminismo.
Bibliogr.: Del piacere e del dolore e altri scritti, a cura di R. De Felice, Milano
1964 (con bibliografia). Su V.: N. Valeri, Pietro Verri, Milano 1937; R. Steiner, Le
« Meditazioni sulla felicità » e il significato della loro doppia redazione nella
storia del pensiero di Pietro Verri, « Giornale storico della letteratura italiana »,
1967; sull’illuminismo lombardo in generale sono da vedere: Aa. Vv., La cultura
illuministica in Italia, a cura di M. Fubini, Torino 1964; F. Venturi, Settecento
riformatore, Torino 1969.
VICO (Giambattista), filosofo italiano (Napoli 1668-1744). Terzultimo degli otto
figli di un libraio poverissimo, ebbe un’infanzia grama, funestata quando aveva circa
sette anni da una caduta che rischiò di compromettere per sempre le sue facoltà
mentali. Dalla frattura del cranio guarì, ma il corpo rimase misero e gracile e la
perenne minaccia della tisi gli valse poi il nomignolo di « maestro Tisicuzzo ». Andò
a scuola, ma studiò soprattutto da solo e a buona ragione gli amici dell’età matura lo
chiamarono « autodidascalo ». A diciotto anni difese con successo il padre in una
causa, ma la precoce esperienza bastò a convincerlo di non essere tagliato per la vita
forense. Accettò perciò con gioia l’offerta di curare l’educazione dei figli del
marchese Rocca e in tale servizio passò nove anni (1686-1695). Non mancarono in
quel periodo i contatti con il mondo culturale napoletano, e in particolare con i
rappresentanti di un nuovo eclettismo, nel quale operavano come fermenti
rinnovatori il cartesianesimo, lo scetticismo libertino, il gassendismo, insieme con
gli echi del naturalismo rinascimentale e della nuova scienza galileiana. Della lettura
di Lucrezio è un riflesso la canzone Affetti di un disperato (1693), il cui cupo
pessimismo restò tuttavia un momento isolato nella vita spirituale del Vico. Nel 1699
vinse la cattedra di eloquenza nell’università di Napoli e si sposò con una donna
analfabeta, che gli dette otto figli. Fra i travagli di una esistenza tribolata Vico portò
avanti l’assiduo colloquio con i suoi « quattro auttori » (Platone, Tacito, Bacone e
Grozio), traendone i primi frutti. Delle « orazioni inaugurali », con le quali egli
apriva di solito i suoi corsi, quella del 1708, intitolata De nostri temporis studiorum
ratione, costituisce un documento importante della sua maturazione filosofica.
Contrapponendosi ai « novatori », che esaltano l’esclusivo valore educatorio delle
matematiche, egli addita la perenne funzione formativa della poesia e della storia,
senza le quali l’animo giovanile rischia di cader preda del nichilismo scettico.
L’opera conclusiva di questo periodo di formazione è Dell’antichissima sapienza
degli Italici* (1710). Gli anni fra il 1717 e il 1732 furono i più tormentati e i più
fecondi della vita del Vico. Subì l’umiliazione di vedersi posposto a un altro nel
concorso per la cattedra di diritto romano (1723), la prima Scienza Nuova* (1725)
fu accolta dall’indifferenza generale. In questo stesso periodo apparvero il De
universi iuris uno principio et fine uno (1720), il De constantia iurisprudentis