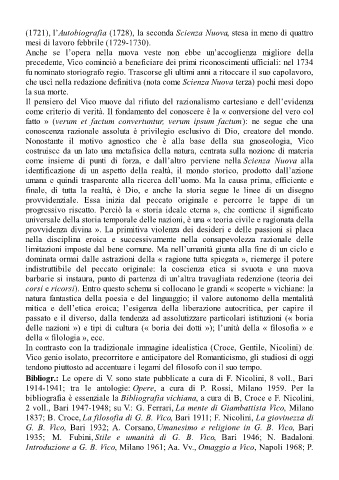Page 862 - Dizionario di Filosofia
P. 862
(1721), l’Autobiografia (1728), la seconda Scienza Nuova, stesa in meno di quattro
mesi di lavoro febbrile (1729-1730).
Anche se l’opera nella nuova veste non ebbe un’accoglienza migliore della
precedente, Vico cominciò a beneficiare dei primi riconoscimenti ufficiali: nel 1734
fu nominato storiografo regio. Trascorse gli ultimi anni a ritoccare il suo capolavoro,
che uscì nella redazione definitiva (nota come Scienza Nuova terza) pochi mesi dopo
la sua morte.
Il pensiero del Vico muove dal rifiuto del razionalismo cartesiano e dell’evidenza
come criterio di verità. Il fondamento del conoscere è la « conversione del vero col
fatto » (verum et factum convertuntur, verum ipsum factum): ne segue che una
conoscenza razionale assoluta è privilegio esclusivo di Dio, creatore del mondo.
Nonostante il motivo agnostico che è alla base della sua gnoseologia, Vico
costruisce da un lato una metafisica della natura, centrata sulla nozione di materia
come insieme di punti di forza, e dall’altro perviene nella Scienza Nuova alla
identificazione di un aspetto della realtà, il mondo storico, prodotto dall’azione
umana e quindi trasparente alla ricerca dell’uomo. Ma la causa prima, efficiente e
finale, di tutta la realtà, è Dio, e anche la storia segue le linee di un disegno
provvidenziale. Essa inizia dal peccato originale e percorre le tappe di un
progressivo riscatto. Perciò la « storia ideale eterna », che contiene il significato
universale della storia temporale delle nazioni, è una « teoria civile e ragionata della
provvidenza divina ». La primitiva violenza dei desideri e delle passioni si placa
nella disciplina eroica e successivamente nella consapevolezza razionale delle
limitazioni imposte dal bene comune. Ma nell’umanità giunta alla fine di un ciclo e
dominata ormai dalle astrazioni della « ragione tutta spiegata », riemerge il potere
indistruttibile del peccato originale: la coscienza etica si svuota e una nuova
barbarie si instaura, punto di partenza di un’altra travagliata redenzione (teoria dei
corsi e ricorsi). Entro questo schema si collocano le grandi « scoperte » vichiane: la
natura fantastica della poesia e del linguaggio; il valore autonomo della mentalità
mitica e dell’etica eroica; l’esigenza della liberazione autocritica, per capire il
passato e il diverso, dalla tendenza ad assolutizzare particolari istituzioni (« boria
delle nazioni ») e tipi di cultura (« boria dei dotti »); l’unità della « filosofia » e
della « filologia », ecc.
In contrasto con la tradizionale immagine idealistica (Croce, Gentile, Nicolini) del
Vico genio isolato, precorritore e anticipatore del Romanticismo, gli studiosi di oggi
tendono piuttosto ad accentuare i legami del filosofo con il suo tempo.
Bibliogr.: Le opere di V. sono state pubblicate a cura di F. Nicolini, 8 voll., Bari
1914-1941; tra le antologie: Opere, a cura di P. Rossi, Milano 1959. Per la
bibliografia è essenziale la Bibliografia vichiana, a cura di B, Croce e F. Nicolini,
2 voll., Bari 1947-1948; su V.: G. Ferrari, La mente di Giambattista Vico, Milano
1837; B. Croce, La filosofia di G. B. Vico, Bari 1911; F. Nicolini, La giovinezza di
G. B. Vico, Bari 1932; A. Corsano, Umanesimo e religione in G. B. Vico, Bari
1935; M. Fubini, Stile e umanità di G. B. Vico, Bari 1946; N. Badaloni,
Introduzione a G. B. Vico, Milano 1961; Aa. Vv., Omaggio a Vico, Napoli 1968; P.