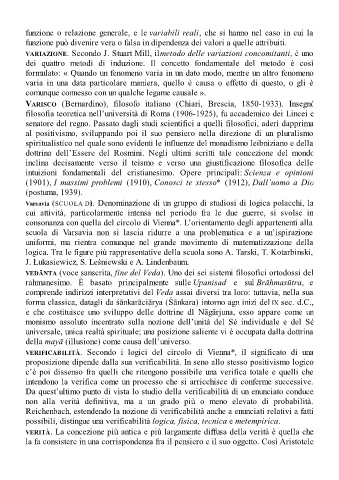Page 858 - Dizionario di Filosofia
P. 858
funzione o relazione generale, e le variabili reali, che si hanno nel caso in cui la
funzione può divenire vera o falsa in dipendenza dei valori a quelle attribuiti.
VARIAZIONE. Secondo J. Stuart Mill, il metodo delle variazioni concomitanti, è uno
dei quattro metodi di induzione. Il concetto fondamentale del metodo è così
formulato: « Quando un fenomeno varia in un dato modo, mentre un altro fenomeno
varia in una data particolare maniera, quello è causa o effetto di questo, o gli è
comunque connesso con un qualche legame causale ».
VARISCO (Bernardino), filosofo italiano (Chiari, Brescia, 1850-1933). Insegnò
filosofia teoretica nell’università di Roma (1906-1925), fu accademico dei Lincei e
senatore del regno. Passato dagli studi scientifici a quelli filosofici, aderì dapprima
al positivismo, sviluppando poi il suo pensiero nella direzione di un pluralismo
spiritualistico nel quale sono evidenti le influenze del monadismo leibniziano e della
dottrina dell’Essere del Rosmini. Negli ultimi scritti tale concezione del mondo
inclina decisamente verso il teismo e verso una giustificazione filosofica delle
intuizioni fondamentali del cristianesimo. Opere principali: Scienza e opinioni
(1901), I massimi problemi (1910), Conosci te stesso* (1912), Dall’uomo a Dio
(postuma, 1939).
Varsavia (SCUOLA DI). Denominazione di un gruppo di studiosi di logica polacchi, la
cui attività, particolarmente intensa nel periodo fra le due guerre, si svolse in
consonanza con quella del circolo di Vienna*. L’orientamento degli appartenenti alla
scuola di Varsavia non si lascia ridurre a una problematica e a un’ispirazione
uniformi, ma rientra comunque nel grande movimento di matematizzazione della
logica. Tra le figure più rappresentative della scuola sono A. Tarski, T. Kotarbinski,
J. Łukasiewicz, S. Leśniewski e A. Lindenbaum.
VEDĀNTA (voce sanscrita, fine del Veda). Uno dei sei sistemi filosofici ortodossi del
rahmanesimo. È basato principalmente sulle Upanisad e sul Brāhmasūtra, e
comprende indirizzi interpretativi del Veda assai diversi tra loro: tuttavia, nella sua
forma classica, datagli da śānkarāciārya (Śānkara) intorno agn inizi del IX sec. d.C.,
e che costituisce uno sviluppo delle dottrine dl Nāgārjuna, esso appare come un
monismo assoluto incentrato sulla nozione dell’unità del Sé individuale e del Sé
universale, unica realtà spirituale; una posizione saliente vi è occupata dalla dottrina
della mayā (illusione) come causa dell’universo.
VERIFICABILITÀ. Secondo i logici del circolo di Vienna*, il significato di una
proposizione dipende dalla sua verificabilità. In seno allo stesso positivismo logico
c’è poi dissenso fra quelli che ritengono possibile una verifica totale e quelli che
intendono la verifica come un processo che si arricchisce di conferme successive.
Da quest’ultimo punto di vista lo studio della verificabilità di un enunciato conduce
non alla verità definitiva, ma a un grado più o meno elevato di probabilità.
Reichenbach, estendendo la nozione di verificabilità anche a enunciati relativi a fatti
possibili, distingue una verificabilità logica, fisica, tecnica e metempirica.
VERITÀ. La concezione più antica e più largamente diffusa della verità è quella che
la fa consistere in una corrispondenza fra il pensiero e il suo oggetto. Così Aristotele