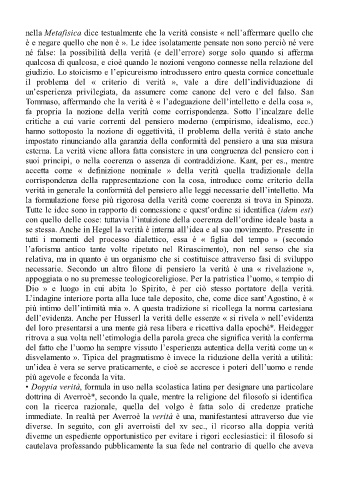Page 859 - Dizionario di Filosofia
P. 859
nella Metafisica dice testualmente che la verità consiste « nell’affermare quello che
è e negare quello che non è ». Le idee isolatamente pensate non sono perciò né vere
né false: la possibilità della verità (e dell’errore) sorge solo quando si afferma
qualcosa di qualcosa, e cioè quando le nozioni vengono connesse nella relazione del
giudizio. Lo stoicismo e l’epicureismo introdussero entro questa cornice concettuale
il problema del « criterio di verità », vale a dire dell’individuazione di
un’esperienza privilegiata, da assumere come canone del vero e del falso. San
Tommaso, affermando che la verità è « l’adeguazione dell’intelletto e della cosa »,
fa propria la nozione della verità come corrispondenza. Sotto l’incalzare delle
critiche a cui varie correnti del pensiero moderno (empirismo, idealismo, ecc.)
hanno sottoposto la nozione di oggettività, il problema della verità è stato anche
impostato rinunciando alla garanzia della conformità del pensiero a una sua misura
esterna. La verità viene allora fatta consistere in una congruenza del pensiero con i
suoi principi, o nella coerenza o assenza di contraddizione. Kant, per es., mentre
accetta come « definizione nominale » della verità quella tradizionale della
corrispondenza della rappresentazione con la cosa, introduce come criterio della
verità in generale la conformità del pensiero alle leggi necessarie dell’intelletto. Ma
la formulazione forse più rigorosa della verità come coerenza si trova in Spinoza.
Tutte le idee sono in rapporto di connessione e quest’ordine si identifica (idem est)
con quello delle cose: tuttavia l’intuizione della coerenza dell’ordine ideale basta a
se stessa. Anche in Hegel la verità è interna all’idea e al suo movimento. Presente in
tutti i momenti del processo dialettico, essa è « figlia del tempo » (secondo
l’aforisma antico tante volte ripetuto nel Rinascimento), non nel senso che sia
relativa, ma in quanto è un organismo che si costituisce attraverso fasi di sviluppo
necessarie. Secondo un altro filone di pensiero la verità è una « rivelazione »,
appoggiata o no su premesse teologicoreligiose. Per la patristica l’uomo, « tempio di
Dio » e luogo in cui abita lo Spirito, è per ciò stesso portatore della verità.
L’indagine interiore porta alla luce tale deposito, che, come dice sant’Agostino, è «
più intimo dell’intimità mia ». A questa tradizione si ricollega la norma cartesiana
dell’evidenza. Anche per Husserl la verità delle essenze « si rivela » nell’evidenza
del loro presentarsi a una mente già resa libera e ricettiva dalla epoché*. Heidegger
ritrova a sua volta nell’etimologia della parola greca che significa verità la conferma
del fatto che l’uomo ha sempre vissuto l’esperienza autentica della verità come un «
disvelamento ». Tipica del pragmatismo è invece la riduzione della verità a utilità:
un’idea è vera se serve praticamente, e cioè se accresce i poteri dell’uomo e rende
più agevole e feconda la vita.
• Doppia verità, formula in uso nella scolastica latina per designare una particolare
dottrina di Averroè*, secondo la quale, mentre la religione del filosofo si identifica
con la ricerca razionale, quella del volgo è fatta solo di credenze pratiche
immediate. In realtà per Averroè la verità è una, manifestantesi attraverso due vie
diverse. In seguito, con gli averroisti del xv sec., il ricorso alla doppia verità
divenne un espediente opportunistico per evitare i rigori ecclesiastici: il filosofo si
cautelava professando pubblicamente la sua fede nel contrario di quello che aveva