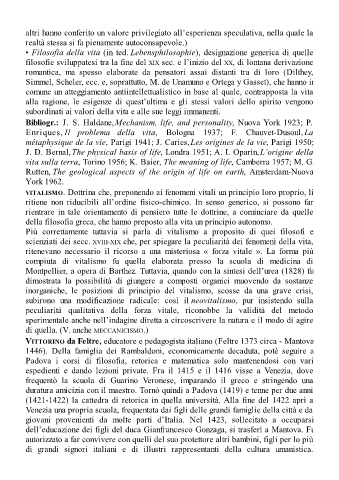Page 865 - Dizionario di Filosofia
P. 865
altri hanno conferito un valore privilegiato all’esperienza speculativa, nella quale la
realtà stessa si fa pienamente autoconsapevole.)
• Filosofia della vita (in ted. Lebensphilosophie), designazione generica di quelle
filosofie sviluppatesi tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX, di lontana derivazione
romantica, ma spesso elaborate da pensatori assai distanti tra di loro (Dilthey,
Simmel, Scheler, ecc. e, soprattutto, M. de Unamuno e Ortega y Gasset), che hanno in
comune un atteggiamento antiintellettualistico in base al quale, contrapposta la vita
alla ragione, le esigenze di quest’ultima e gli stessi valori dello spirito vengono
subordinati ai valori della vita e alle sue leggi immanenti.
Bibliogr.: J. S. Haldane, Mechanism, life, and personality, Nuova York 1923; P.
Enriques, Il problema della vita, Bologna 1937; F. Chauvet-Dusoul, La
métaphysique de la vìe, Parigi 1941; J. Caries, Les origines de la vie, Parigi 1950;
J. D. Bernal, The physical basis of life, Londra 1951; A. I. Oparin, L’origine della
vita sulla terra, Torino 1956; K. Baier, The meaning of life, Camberra 1957; M. G.
Rutten, The geological aspects of the origin of life on earth, Amsterdam-Nuova
York 1962.
VITALISMO. Dottrina che, preponendo ai fenomeni vitali un principio loro proprio, li
ritiene non riducibili all’ordine fisico-chimico. In senso generico, si possono far
rientrare in tale orientamento di pensiero tutte le dottrine, a cominciare da quelle
della filosofia greca, che hanno preposto alla vita un principio autonomo.
Più correttamente tuttavia si parla di vitalismo a proposito di quei filosofi e
scienziati dei secc. XVIII-XIX che, per spiegare la peculiarità dei fenomeni della vita,
ritenevano necessario il ricorso a una misteriosa « forza vitale ». La forma più
compiuta di vitalismo fu quella elaborata presso la scuola di medicina di
Montpellier, a opera di Barthez. Tuttavia, quando con la sintesi dell’urea (1828) fu
dimostrata la possibilità di giungere a composti organici muovendo da sostanze
inorganiche, le posizioni di principio del vitalismo, scosse da una grave crisi,
subirono una modificazione radicale: così il neovitalismo, pur insistendo sulla
peculiarità qualitativa della forza vitale, riconobbe la validità del metodo
sperimentale anche nell’indagine diretta a circoscrivere la natura e il modo di agire
di quella. (V. anche MECCANICISMO.)
VITTORINO da Feltre, educatore e pedagogista italiano (Feltre 1373 circa - Mantova
1446). Della famiglia dei Rambaldoni, economicamente decaduta, poté seguire a
Padova i corsi di filosofia, retorica e matematica solo mantenendosi con vari
espedienti e dando lezioni private. Fra il 1415 e il 1416 visse a Venezia, dove
frequentò la scuola di Guarino Veronese, imparando il greco e stringendo una
duratura amicizia con il maestro. Tornò quindi a Padova (1419) e tenne per due anni
(1421-1422) la cattedra di retorica in quella università. Alla fine del 1422 aprì a
Venezia una propria scuola, frequentata dai figli delle grandi famiglie della città e da
giovani provenienti da molte parti d’Italia. Nel 1423, sollecitato a occuparsi
dell’educazione dei figli del duca Gianfrancesco Gonzaga, si trasferì a Mantova. Fu
autorizzato a far convivere con quelli del suo protettore altri bambini, figli per lo più
di grandi signori italiani e di illustri rappresentanti della cultura umanistica.