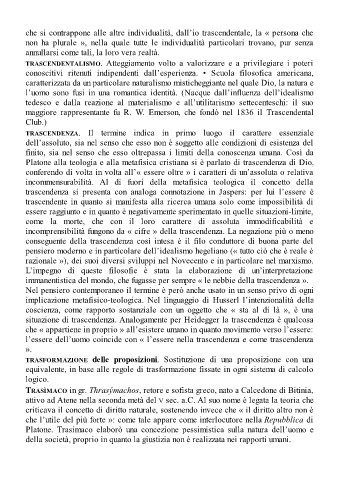Page 844 - Dizionario di Filosofia
P. 844
che si contrappone alle altre individualità, dall’io trascendentale, la « persona che
non ha plurale », nella quale tutte le individualità particolari trovano, pur senza
annullarsi come tali, la loro vera realtà.
TRASCENDENTALISMO. Atteggiamento volto a valorizzare e a privilegiare i poteri
conoscitivi ritenuti indipendenti dall’esperienza. • Scuola filosofica americana,
caratterizzata da un particolare naturalismo misticheggiante nel quale Dio, la natura e
l’uomo sono fusi in una romantica identità. (Nacque dall’influenza dell’idealismo
tedesco e dalla reazione al materialismo e all’utilitarismo settecenteschi: il suo
maggiore rappresentante fu R. W. Emerson, che fondò nel 1836 il Trascendental
Club.)
TRASCENDENZA. Il termine indica in primo luogo il carattere essenziale
dell’assoluto, sia nel senso che esso non è soggetto alle condizioni di esistenza del
finito, sia nel senso che esso oltrepassa i limiti della conoscenza umana. Così da
Platone alla teologia e alla metafisica cristiana si è parlato di trascendenza di Dio,
conferendo di volta in volta all’« essere oltre » i caratteri di un’assoluta o relativa
incommensurabilità. Al di fuori della metafisica teologica il concetto della
trascendenza si presenta con analoga connotazione in Jaspers: per lui l’essere è
trascendente in quanto si manifesta alla ricerca umana solo come impossibilità di
essere raggiunto e in quanto è negativamente sperimentato in quelle situazioni-limite,
come la morte, che con il loro carattere di assoluta immodificabilità e
incomprensibilità fungono da « cifre » della trascendenza. La negazione più o meno
conseguente della trascendenza così intesa è il filo conduttore di buona parte del
pensiero moderno e in particolare dell’idealismo hegeliano (« tutto ciò che è reale è
razionale »), dei suoi diversi sviluppi nel Novecento e in particolare nel marxismo.
L’impegno di queste filosofie è stata la elaborazione di un’interpretazione
immanentistica del mondo, che fugasse per sempre « le nebbie della trascendenza ».
Nel pensiero contemporaneo il termine è però anche usato in un senso privo di ogni
implicazione metafisico-teologica. Nel linguaggio di Husserl l’intenzionalità della
coscienza, come rapporto sostanziale con un oggetto che « sta al di là », è una
situazione di trascendenza. Analogamente per Heidegger la trascendenza è qualcosa
che « appartiene in proprio » all’esistere umano in quanto movimento verso l’essere:
l’essere dell’uomo coincide con « l’essere nella trascendenza e come trascendenza
».
TRASFORMAZIONE delle proposizioni. Sostituzione di una proposizione con una
equivalente, in base alle regole di trasformazione fissate in ogni sistema di calcolo
logico.
TRASÌMACO in gr. Thrasýmachos, retore e sofista greco, nato a Calcedone di Bitinia,
attivo ad Atene nella seconda metà del V sec. a.C. Al suo nome è legata la teoria che
criticava il concetto di diritto naturale, sostenendo invece che « il diritto altro non è
che l’utile del più forte »: come tale appare come interlocutore nella Repubblica di
Platone. Trasimaco elaborò una concezione pessimistica sulla natura dell’uomo e
della società, proprio in quanto la giustizia non è realizzata nei rapporti umani.