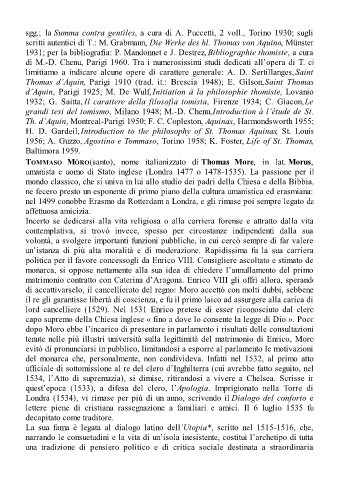Page 841 - Dizionario di Filosofia
P. 841
sgg.; la Summa contra gentiles, a cura di A. Puccetti, 2 voll., Torino 1930; sugli
scritti autentici di T.: M. Grabmann, Die Werke des hl. Thomas von Aquino, Münster
1931; per la bibliografia: P. Mandonnet e J. Destrez, Bibliographie thomiste, a cura
di M.-D. Chenu, Parigi 1960. Tra i numerosissimi studi dedicati all’opera di T. ci
limitiamo a indicare alcune opere di carattere generale: A. D. Sertillanges, Saint
Thomas d’Aquin, Parigi 1910 (trad. it.: Brescia 1948); E. Gilson, Saint Thomas
d’Aquin, Parigi 1925; M. De Wulf, Initiation à la philosophie thomiste, Lovanio
1932; G. Saitta, Il carattere della filosofia tomista, Firenze 1934; C. Giacon, Le
grandi tesi del tomismo, Milano 1948; M.-D. Chenu, Introduction à l’étude de St.
Th. d’Aquin, Montreal-Parigi 1950; F. C. Copleston, Aquinas, Harmondsworth 1955;
H. D. Gardeil, Introduction to the philosophy of St. Thomas Aquinas, St. Louis
1956; A. Guzzo, Agostino e Tommaso, Torino 1958; K. Foster, Life of St. Thomas,
Baltimora 1959.
TOMMASO MÒRO(santo), nome italianizzato di Thomas More, in lat. Morus,
umanista e uomo di Stato inglese (Londra 1477 o 1478-1535). La passione per il
mondo classico, che si univa in lui allo studio dei padri della Chiesa e della Bibbia,
ne fecero presto un esponente di primo piano della cultura umanistica ed erasmiana:
nel 1499 conobbe Erasmo da Rotterdam a Londra, e gli rimase poi sempre legato da
affettuosa amicizia.
Incerto se dedicarsi alla vita religiosa o alla carriera forense e attratto dalla vita
contemplativa, si trovò invece, spesso per circostanze indipendenti dalla sua
volontà, a svolgere importanti funzioni pubbliche, in cui cercò sempre di far valere
un’istanza di più alta moralità e di moderazione. Rapidissima fu la sua carriera
politica per il favore concessogli da Enrico VIII. Consigliere ascoltato e stimato del
monarca, si oppose nettamente alla sua idea di chiedere l’annullamento del primo
matrimonio contratto con Caterina d’Aragona. Enrico VIII gli offrì allora, sperando
di accattivarselo, il cancellierato del regno: Moro accettò con molti dubbi, sebbene
il re gli garantisse libertà di coscienza, e fu il primo laico ad assurgere alla carica di
lord cancelliere (1529). Nel 1531 Enrico pretese di esser riconosciuto dal clero
capo supremo della Chiesa inglese « fino a dove lo consente la legge di Dio ». Poco
dopo Moro ebbe l’incarico di presentare in parlamento i risultati delle consultazioni
tenute nelle più illustri università sulla legittimità del matrimonio di Enrico, Moro
evitò di pronunciarsi in pubblico, limitandosi a esporre al parlamento le motivazioni
del monarca che, personalmente, non condivideva. Infatti nel 1532, al primo atto
ufficiale di sottomissione al re del clero d’Inghilterra (cui avrebbe fatto seguito, nel
1534, l’Atto di supremazia), si dimise, ritirandosi a vivere a Chelsea. Scrisse in
quest’epoca (1533), a difesa del clero, l’Apologia. Imprigionato nella Torre di
Londra (1534), vi rimase per più di un anno, scrivendo il Dialogo del conforto e
lettere piene di cristiana rassegnazione a familiari e amici. Il 6 luglio 1535 fu
decapitato come traditore.
La sua fama è legata al dialogo latino dell’Utopia*, scritto nel 1515-1516, che,
narrando le consuetudini e la vita di un’isola inesistente, costituì l’archetipo di tutta
una tradizione di pensiero politico e di critica sociale destinata a straordinaria