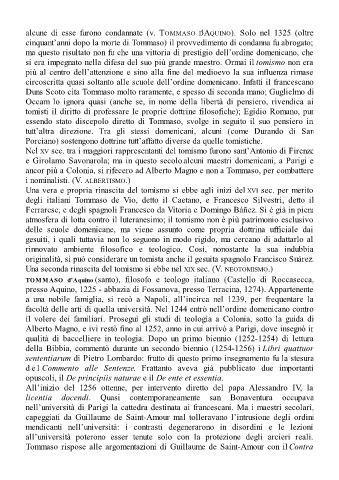Page 837 - Dizionario di Filosofia
P. 837
alcune di esse furono condannate (v. TOMMASO D’AQUINO). Solo nel 1325 (oltre
cinquant’anni dopo la morte di Tommaso) il provvedimento di condanna fu abrogato;
ma questo risultato non fu che una vittoria di prestigio dell’ordine domenicano, che
si era impegnato nella difesa del suo più grande maestro. Ormai il tomismo non era
più al centro dell’attenzione e sino alla fine del medioevo la sua influenza rimase
circoscritta quasi soltanto alle scuole dell’ordine domenicano. Infatti il francescano
Duns Scoto cita Tommaso molto raramente, e spesso di seconda mano; Guglielmo di
Occam lo ignora quasi (anche se, in nome della libertà di pensiero, rivendica ai
tomisti il diritto di professare le proprie dottrine filosofiche); Egidio Romano, pur
essendo stato discepolo diretto di Tommaso, svolge in seguito il suo pensiero in
tutt’altra direzione. Tra gli stessi domenicani, alcuni (come Durando di San
Porciano) sostengono dottrine tutt’affatto diverse da quelle tomistiche.
Nel XV sec. tra i maggiori rappresentanti del tomismo furono sant’Antonio di Firenze
e Girolamo Savonarola; ma in questo secolo alcuni maestri domenicani, a Parigi e
ancor più a Colonia, si rifecero ad Alberto Magno e non a Tommaso, per combattere
i nominalisti. (V. ALBERTISMO.)
Una vera e propria rinascita del tomismo si ebbe agli inizi del XVI sec. per merito
degli italiani Tommaso de Vio, detto il Caetano, e Francesco Silvestri, detto il
Ferrarese, e degli spagnoli Francesco da Vitoria e Domingo Báñez. Si è già in piena
atmosfera di lotta contro il luteranesimo; il tomismo non è più patrimonio esclusivo
delle scuole domenicane, ma viene assunto come propria dottrina ufficiale dai
gesuiti, i quali tuttavia non lo seguono in modo rigido, ma cercano di adattarlo al
rinnovato ambiente filosofico e teologico. Così, nonostante la sua indubbia
originalità, si può considerare un tomista anche il gesuita spagnolo Francisco Suárez.
Una seconda rinascita del tomismo si ebbe nel XIX sec. (V. NEOTOMISMO.)
TOMMASO d’Aquino (santo), filosofo e teologo italiano (Castello di Roccasecca,
presso Aquino, 1225 - abbazia di Fossanova, presso Terracina, 1274). Appartenente
a una nobile famiglia, si recò a Napoli, all’incirca nel 1239, per frequentare la
facoltà delle arti di quella università. Nel 1244 entrò nell’ordine domenicano contro
il volere dei familiari. Proseguì gli studi di teologia a Colonia, sotto la guida di
Alberto Magno, e ivi restò fino al 1252, anno in cui arrivò a Parigi, dove insegnò in
qualità di baccelliere in teologia. Dopo un primo biennio (1252-1254) di lettura
della Bibbia, commentò durante un secondo biennio (1254-1256) i Libri quattuor
sententiarum di Pietro Lombardo: frutto di questo primo insegnamento fu la stesura
d e l Commento alle Sentenze. Frattanto aveva già pubblicato due importanti
opuscoli, il De principiis naturae e il De ente et essentia.
All’inizio del 1256 ottenne, per intervento diretto del papa Alessandro IV, la
licentia docendi. Quasi contemporaneamente san Bonaventura occupava
nell’università di Parigi la cattedra destinata ai francescani. Ma i maestri secolari,
capeggiati da Guillaume de Saint-Amour mal tolleravano l’intrusione degli ordini
mendicanti nell’università: i contrasti degenerarono in disordini e le lezioni
all’università poterono esser tenute solo con la protezione degli arcieri reali.
Tommaso rispose alle argomentazioni di Guillaume de Saint-Amour con il Contra