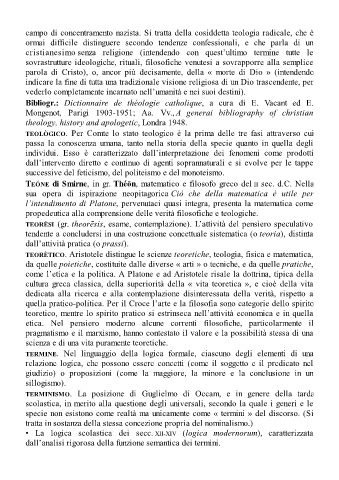Page 832 - Dizionario di Filosofia
P. 832
campo di concentramento nazista. Si tratta della cosiddetta teologia radicale, che è
ormai difficile distinguere secondo tendenze confessionali, e che parla di un
cristianesimo senza religione (intendendo con quest’ultimo termine tutte le
sovrastrutture ideologiche, rituali, filosofiche venutesi a sovrapporre alla semplice
parola di Cristo), o, ancor più decisamente, della « morte di Dio » (intendendo
indicare la fine di tutta una tradizionale visione religiosa di un Dio trascendente, per
vederlo completamente incarnato nell’umanità e nei suoi destini).
Bibliogr.: Dictionnaire de théologie catholique, a cura di E. Vacant ed E.
Mongenot, Parigi 1903-1951; Aa. Vv., A generai bibliography of christian
theology, history and apologetic, Londra 1948.
TEOLÒGICO. Per Comte lo stato teologico è la prima delle tre fasi attraverso cui
passa la conoscenza umana, tanto nella storia della specie quanto in quella degli
individui. Esso è caratterizzato dall’interpretazione dei fenomeni come prodotti
dall’intervento diretto e continuo di agenti soprannaturali e si evolve per le tappe
successive del feticismo, del politeismo e del monoteismo.
TEÓNE di Smirne, in gr. Théōn, matematico e filosofo greco del II sec. d.C. Nella
sua opera di ispirazione neopitagorica Ciò che della matematica è utile per
l’intendimento di Platone, pervenutaci quasi integra, presenta la matematica come
propedeutica alla comprensione delle verità filosofiche e teologiche.
TEORÈSI (gr. theorēsis, esame, contemplazione). L’attività del pensiero speculativo
tendente a concludersi in una costruzione concettuale sistematica (o teoria), distinta
dall’attività pratica (o prassi).
TEORÈTICO. Aristotele distingue le scienze teoretiche, teologia, fisica e matematica,
da quelle poietiche, costituite dalle diverse « arti » o tecniche, e da quelle pratiche,
come l’etica e la politica. A Platone e ad Aristotele risale la dottrina, tipica della
cultura greca classica, della superiorità della « vita teoretica », e cioè della vita
dedicata alla ricerca e alla contemplazione disinteressata della verità, rispetto a
quella pratico-politica. Per il Croce l’arte e la filosofia sono categorie dello spirito
teoretico, mentre lo spirito pratico si estrinseca nell’attività economica e in quella
etica. Nel pensiero moderno alcune correnti filosofiche, particolarmente il
pragmatismo e il marxismo, hanno contestato il valore e la possibilità stessa di una
scienza e di una vita puramente teoretiche.
TERMINE. Nel linguaggio della logica formale, ciascuno degli elementi di una
relazione logica, che possono essere concetti (come il soggetto e il predicato nel
giudizio) o proposizioni (come la maggiore, la minore e la conclusione in un
sillogismo).
TERMINISMO. La posizione di Guglielmo di Occam, e in genere della tarda
scolastica, in merito alla questione degli universali, secondo la quale i generi e le
specie non esistono come realtà ma unicamente come « termini » del discorso. (Si
tratta in sostanza della stessa concezione propria del nominalismo.)
• La logica scolastica dei secc. XII-XIV (logica modernorum), caratterizzata
dall’analisi rigorosa della funzione semantica dei termini.